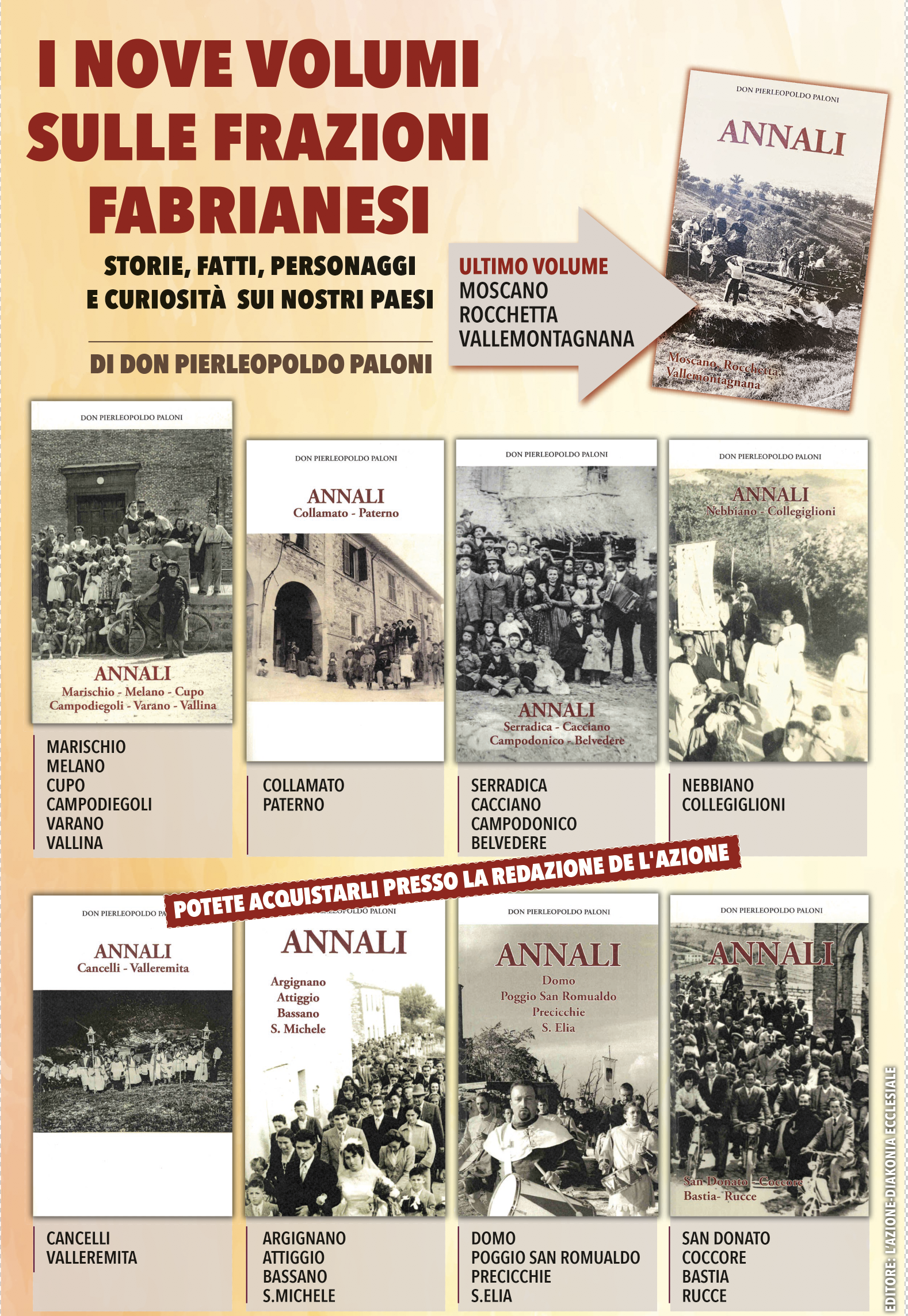La tagliola dei social
«Un grammo di buon esempio vale più di un quintale di parole» diceva San Francesco di Sales. Si tratta del patrono dei giornalisti, festeggiato qualche settimana fa. Quando morì, nel 1622, i media non esistevano ancora. E tantomeno i social network. Eppure lui per raggiungere i fedeli più lontani scelse il dialogo, inventando i cosiddetti «manifesti». Erano fogli volanti, che venivano affissi ai muri o fatti scivolare sotto le porte delle case. Quasi 500 anni dopo sul profilo Twitter di Papa Francesco è apparsa questa riflessione: “Non sottovalutiamo il valore dell’esempio perché ha più forza di mille parole, di migliaia di likes o retweets, di mille video su Youtube. Non una critica tout court ai social. Né tantomeno ai tanti che ogni giorno li usano. Ma un richiamo alla concretezza. Perché – a differenza di quello che credono molti – i social non sono un mondo virtuale o uno spazio a sé, ma un'occasione di relazione. Semmai – «occorre interrogarsi su ciò che in Rete e sui social è buono, facendo riferimento ai valori propri di una visione dell'uomo e del mondo, una visione della persona in tutte le sue dimensioni, soprattutto quella trascendente». Non è la prima volta che il Papa parla dei social network. Ricordo altri passi significativi, messi da parte nella scrivania di lavoro, ma mi sfugge in quale occasione: «Internet può offrire maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti, e questa è una cosa buona, è un dono di Dio. Esistono però aspetti problematici: la velocità dell'informazione supera la nostra capacità di riflessione e giudizio e non permette un'espressione di sé misurata e corretta. [...] L'ambiente comunicativo può aiutarci a crescere o, al contrario, a disorientarci. Il desiderio di connessione digitale può finire per isolarci dal nostro prossimo, da chi ci sta più vicino». E ancora: «Questi limiti sono reali, tuttavia non giustificano un rifiuto dei media sociali; piuttosto ci ricordano che la comunicazione è, in definitiva, una conquista più umana che tecnologica». Umana sì, e lo avvertiamo in maniera micidiale. Infatti sono gli uomini i protagonisti di un utilizzo spesso infernale dalle conseguenze tragiche. Come la storia di Gian Marco nel Bresciano. Un anno fa era emozionato come una matricola, la placca dorata sul petto, è il suo primo encomio ufficiale. Nella fotografia i colleghi gioiscono con lui. 20 gennaio 2019. Un anno prima dell’abisso. Esattamente 399 giorni dopo, per un parcheggio vietato — un vigile che mette l’auto di servizio su un posto riservato ai disabili — si scatenerà la gogna dei social. Sarà l’innesco della fine. Non è un ragazzino, non è perseguitato dai compagni di scuola. È un pubblico ufficiale che a 44 anni si toglie la vita perché non riesce a sopportare la condanna del tribunale virtuale: i social network. Fuori da un ateneo per un corso di anti-infortunistica l’auto della polizia locale è parcheggiata sulle strisce del posteggio riservato ai disabili. Alla guida c’era lui, Gian Marco L’immagine viene catturata da uno smartphone: rilanciata sui social, per denunciare il fatto, la notizia inizia a girare: dappertutto, anche sui giornali locali. Comunque prima che i gruppi Facebook iniziassero a rovesciargli addosso il repertorio che, nel tempo dell’odio in tempo reale, può toccare a un vigile che ha commesso un errore sì, plateale, lui si era già scusato, con tanto di autopunizione e donazione. Messaggi di questo tenore: «Meglio ridere, altrimenti è meglio spararsi». «Vergognati». «Ecco gli abusi di potere». «Incivile, è così che dai l’esempio!». «Puoi anche ammazzarti». Gian Marco l’ha fatto davvero. L’agente che l’anno scorso era stato premiato perché aveva fermato un’auto rubata con a bordo gli attrezzi dei rapinatori — armi finte, attrezzi da scasso, passamontagna — si è tirato un colpo con la pistola d’ordinanza. La soluzione più estrema per togliersi di dosso l’onta del vigile che sulla pubblica via occupa lo spazio destinato ai veicoli dei portatori di handicap. Una storia agghiacciante dove alla fine, forse, perdono tutti. Una storia come altre, dove troviamo vittime di derisione, di bullismo, di diffamazione. Meschinità e bassezze antiche che il nostro mondo dei social purtroppo amplifica, moltiplica, fa esplodere. La domanda è impellente: perché mettere la foto sui social quando bastava consegnarla al comando della Polizia locale e chiedere eventualmente una sanzione? Perché sono sempre tanti gli improvvisati e spietati giudici pronti a battere sulla tastiera del web? Non è venuto in mente a nessuno che distruggere una reputazione è più grave che parcheggiare nel posto dei disabili? Proprio vero, la reputazione. Sapere di essere considerati bene o male, godere o non godere della stima altrui, cambia non solo il nostro modo di sentirci, ma pure il nostro modo di essere. Il giudizio degli altri ci costituisce perché noi ci sentiamo, anzi noi siamo, noi diventiamo quello che gli altri vedono in noi. Vale per l’immagine pubblica e per quella privata. Se proprio vogliamo fare una grossolana distinzione, magari sul lavoro abbiamo bisogno di sentirci stimati, mentre nei rapporti familiari o comunque sentimentali, abbiamo bisogno di sentirci amati. Ecco perché quando crolla una reputazione, o quando si scopre di non essere amati, materialmente, quindi apparentemente, non perdiamo nulla, ma in realtà perdiamo tutto. Noi ci vediamo con gli occhi del nostro prossimo, di chi ci sta vicino e quando questi occhi ci giudicano impietosamente, senza misericordia, siamo noi stessi i primi a non perdonarci. Ma siamo ancora in tempo a recuperare quel briciolo di umanità che spesso il pur apprezzato mondo dei social ci toglie senza accorgerci.