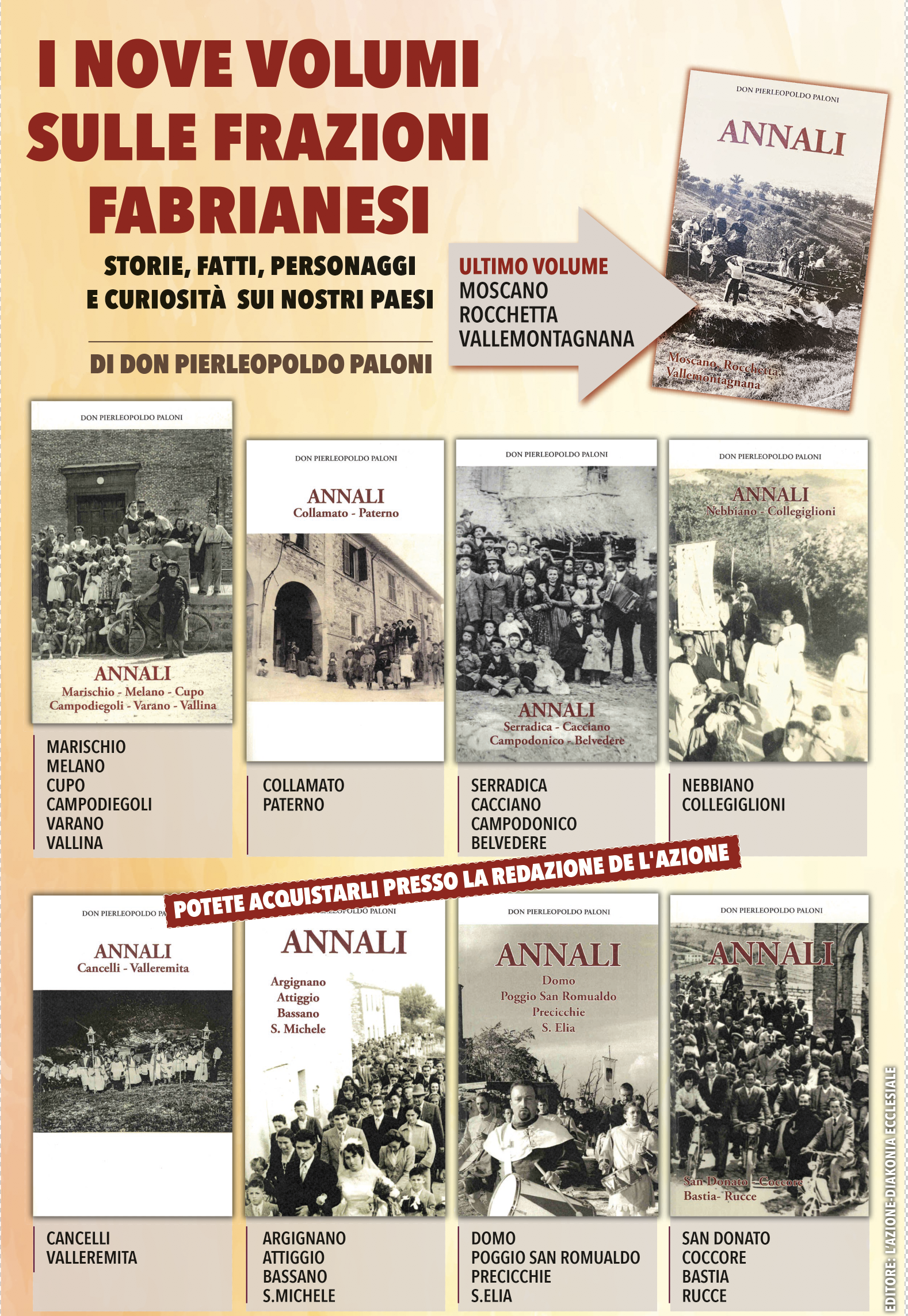Il virus e la paura
Torniamo a parlarne, non perché ci accodiamo alle preoccupazioni generali (pur sempre legittime) ma perché ormai sta pilotando e gestendo ogni nostro atto. Sì, il virus ha preso la supremazia su tutto e ci ricorda ancora una volta la nostra fragilità di fronte alla realtà. Siamo in Quaresima e questo periodo di preparazione alla Pasqua non è altro che un cammino, sarebbe meglio dire una sorta di ascesi, per sentire carne una visione dell’uomo lontana dall’idea che siamo gli unici padroni del nostro destino. Forse avremmo evitato di far coincidere l’ordinanza di sospensione di ogni attività aggregativa la vigilia delle Ceneri e con più buon senso avremmo permesso una piccola deroga o un ritardo di emanazione del provvedimento. Ma il mondo, questo spicchio di mondo che viviamo ci conferma in modo strano, spesso drammatico o ancora splendido, che la fede non è proprio una stupida messa in scena, un oppio rigenerante, ma la possibilità di scoprire la vita come un compito di bene. Perché senza senso del compito di bene, il vivere diviene un viaggio senza scopo. Adesso allora non si può più cincischiare, traccheggiare, né buttarla in politica. Perché da un giorno all’altro per numero di persone infettate dal coronavirus siamo balzati in testa alla classifica dei paesi occidentali. Ed è arrivata la paura. Da non censurare, tutt’altro. Essa può aiutarci ad assumere comportamenti prudenti e responsabili, se ci prende in misura ragionevole e se trova un contesto favorevole: indicazioni chiare delle autorità competenti, abolizione delle recriminazioni tra le forze politiche, fiducia nell’ottimo sistema sanitario che abbiamo, cura della corretta informazione da parte di chi la divulga, attenzione all’attendibilità e autorevolezza delle fonti da parte dei fruitori. Orecchio da mercante alle chiacchiere da social. Imparare comportamenti virtuosi è un bell’esercizio di responsabilità verso se stessi e verso gli altri. Tuttavia è il caso di guardarla un po’ bene in faccia questa paura, che ricorrentemente ci assale (per gli attentati terroristici, per un’epidemia, per l’Aids, la Sars, lo tsunami), e poi ci passa, di solito senza farci fare un passo avanti. Un filone di riflessione in questi giorni sembra essersi aperto sulla stampa: sul Corsera viene messo in luce che c’è una peculiare paura moderna che nasce in un mondo dove “la situazione è sotto controllo”, dove tutto si presume sottoponibile al controllo grazie al potere delle tecnoscienze, alla razionalità che tutto indaga, conosce, prevede e doma. È indiscutibile che le scienze e le tecnologie hanno fatto enormi progressi; nel caso di questa epidemia, il virus è stato isolato in sette giorni e sequenziato in quindici, cioè in tempi rapidissimi. Ma non è vero che l’uomo abbia tutto sotto controllo. Questa presunzione spesso si rivela un’illusione e andiamo in tilt quando accade un imprevisto. Ma appena la situazione torna alla “normalità”, ce ne scordiamo. L’idea che ci sia una imprevedibilità non l’accettiamo, la esorcizziamo. Rovesciamo il famoso “un imprevisto è la sola speranza” del poeta Montale. Le nostre paure rivelano generalmente un’insicurezza esistenziale di fondo e permanente. Per Zygmunt Bauman, essa è dovuta “all’indebolimento dei legami, allo sgretolamento delle comunità, alla sostituzione della solidarietà umana con la competizione”. Per Antonio Scurati si ha la prova che la “modernità ha fallito”. Perché, ha scritto, “…nei nostri comodi letti insonni dei nostri accoglienti appartamenti d’Occidente… siamo al sicuro, siamo protetti, siamo ben coperti e, forse, proprio per questo, tremiamo al pensiero di una morte che giunga come ospite inatteso”. E ancora: “Non siamo più capaci di equilibrato, adulto, sano rapporto con la morte”; “è finita in crisi la cognizione della finitudine umana”. Nelle società tradizionali (e più religiose) la morte era parte della vita, personale e collettiva; era parte della definizione stessa della vita (Huizinga), un evento familiare; per la società odierna la morte è estranea alla vita, e va rimossa. Ma i fatti, gli irriducibili fatti, ci riportano alla realtà e ci mettono davanti alla domanda: che senso ha vivere? Perché vale la pena vivere? Si leggeva su un volantino diffuso all’indomani della strage terroristica di Parigi nel novembre 2015: “Cercare una risposta adeguata alla domanda sul significato della vita è l’unico antidoto alla paura che ci assale”. Verissimo. Ma proprio ora che un intero Paese è spaventato occorre reagire. Accettando la situazione di emergenza, la convivenza con il pericolo, lo stop o il rallentamento al nostro ritmo di vita. La storia dell’umanità è fatta anche di queste cose, di interruzioni della normalità che si chiamano pestilenze, terremoti, alluvioni. E questa del coronavirus – lo confermano i dati sulla mortalità – non è certo una delle peggiori. Bisogna saper convivere con la difficoltà e perfino con la paura, usando la ragione, la quale ci pone subito come evidenza, la sproporzione fra il coprifuoco ed il pericolo. Era necessario prendere provvedimenti così: ma stiamo parlando di una malattia dalla quale quasi sempre si guarisce. La peste, il colera, l’alluvione, insomma la calamità ci invitano a guardare all’essenziale, a ricondurre nell’angolo tanti nostri affanni della quotidiana normalità. “Si potrebbe… osservare, ascoltare, paragonare, pensare, prima di parlare. Ma parlare, questa cosa così sola, è talmente più facile di tutte quell’altre insieme, che anche noi, dico noi uomini in generale, siamo un po’ da compatire”. Sono espressioni che appartengono ad una fase dove i social nemmeno esistevano. Sono tratte dal capitolo sulla peste di Alessandro Manzoni de “I Promessi Sposi”. Ogni tanto non si sbaglia a guardare indietro per imparare a camminare meglio in avanti.