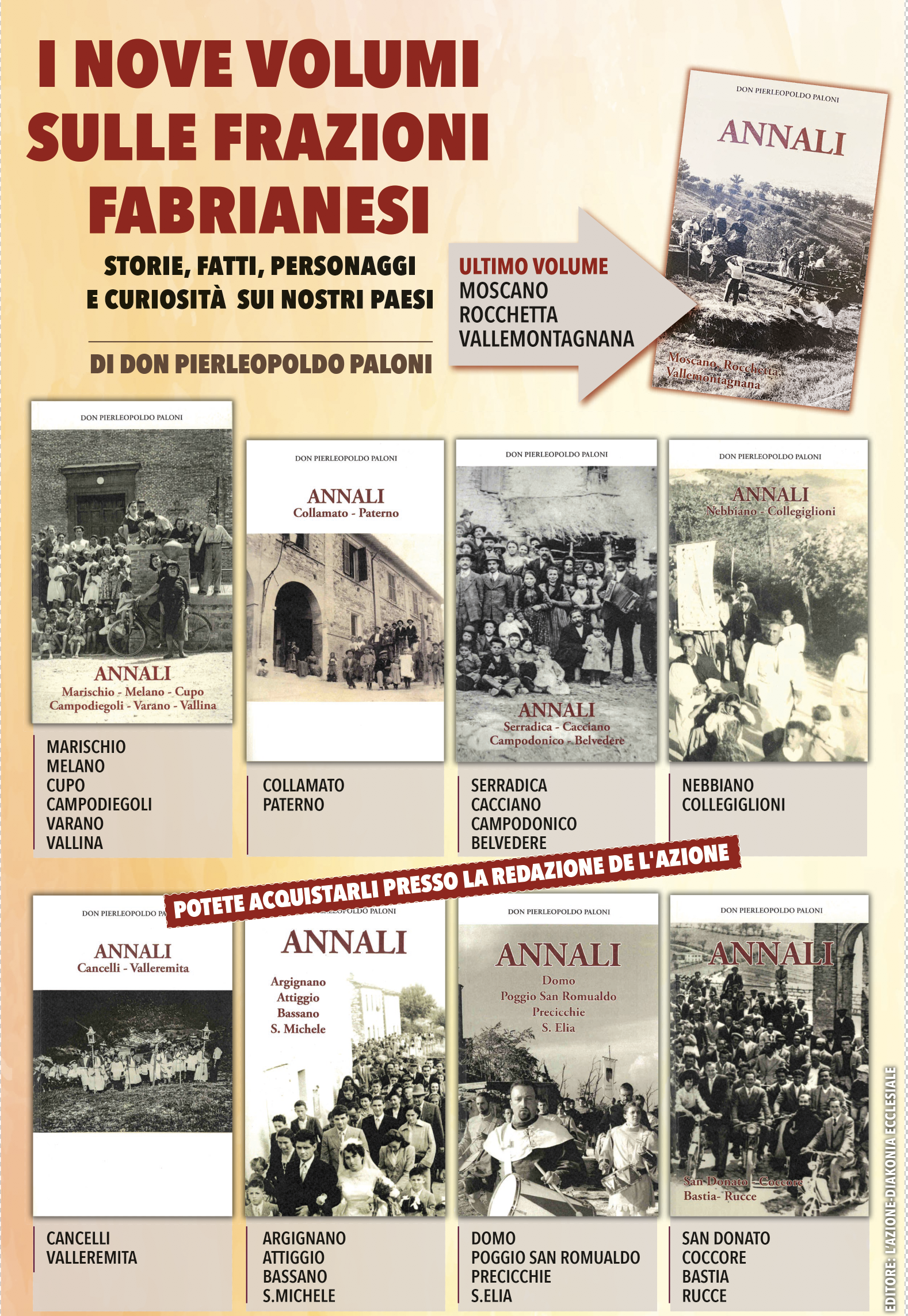Le domande sulla guerra
Invasione, truppe, bombardamenti. Il vocabolario bellico che pensavamo di aver consegnato per sempre alla storia torna improvvisamente a occupare i nostri cuori e le nostre menti. Proprio come due anni fa con la pandemia – che ci sorprese, piombandoci addosso dalla Cina – così in questo febbraio 2022 siamo spettatori dell’inizio di un conflitto nel cuore dell’Europa che Stoltenberg, il segretario generale della Nato, ha definito «il più pericoloso dal 1945». Guerra e pandemia, dunque, parole antiche che dalle profondità ancestrali delle vicende umane riemergono e acquistano nuovo significato nel tempo in cui viviamo. Da diversi anni Papa Francesco ha usato l’espressione «guerra mondiale a pezzi» per dire che la prima fase della globalizzazione – quella iniziata con la caduta del muro di Berlino, con il disegno di un’unificazione planetaria nel segno della crescita e del mercato – ha ormai da tempo dato vita a un quadro molto più controverso. Dove si moltiplicano i fronti di tensione e conflitto. Il terrorismo internazionale, l’edificazione di muri, i conflitti armati, le guerre civili, le persecuzioni delle minoranze etniche e religiose sono le tante espressioni del disordine che regna a livello internazionale. Nella fase matura del mondo globalizzato è in atto un lento e delicatissimo processo di formazione di aree politiche-economiche-culturali omogenee che cercano di ridefinire il loro posizionamento strategico a livello regionale e globale. Prima di tutto, la tensione si gioca sui tanti confini non stabilizzati dove si scaricano i disegni di potenza. L’Ucraina fa parte della storia russa oppure no? Contese pericolosissime perché, come insegna la storia, non hanno mai una soluzione definitiva. L’alternativa alla strada che porta a massacri, pulizie etiche, guerre fratricide è la ricerca di composizioni che possono nascere solo attraverso l’ascolto e il dialogo. Nel moltiplicarsi di questi terreni di scontro, appare altresì evidente la fallacia del pensiero che ha immaginato la semplice eliminazione di ogni confine: aver cercato di negare la pluralità delle storie culturali ha finito per produrre, per reazione, l’affermazione violenta del confine. Come dominio, possesso, chiusura. Quando invece sappiamo che il confine è anche il punto di congiunzione della diversità e perciò luogo possibile del dialogo e dell’incontro. La guerra oggi si produce nel quadro di una interdipendenza economica e tecnologica che lega insieme interessi diversi e spesso divergenti. Ciò vuol dire che, ben al di là del teatro degli scontri, ci si combatte anche attraverso le ritorsioni economiche, commerciali, finanziarie. Una guerra quindi molto più complessa e sofisticata che, nel caso ucraino, è già cominciata: Putin ha in mano l’arma delle forniture di gas, grano e mais; Biden ha già annunciato misure come il taglio dei finanziamenti occidentali al debito sovrano russo. E non si può dimenticare l’inevitabile spostamento di popolazione: quanti profughi arriveranno nella Ue, con quali conseguenze umanitarie ed effetti politici? È proprio questa interdipendenza che deve preoccupare, perché diventa molto difficile per qualunque attore in campo calcolare le conseguenze delle proprie iniziative.?Non siamo di fronte a una guerra tradizionale o a una guerriglia. La “guerra ibrida”, di cui la Russia è esperta, presuppone l’uso sistematico della disinformazione, la strumentalizzazione dei migranti, l’intervento con fake news nei processi elettorali dell’Occidente, come è già successo negli Stati Uniti. La sfida ai nostri sistemi democratici non sarà esterna, ma interna. Ed è per questo che in questa guerra siamo tutti protagonisti. Stiamo già ricevendo false informazioni volte non solo a generare sostegno per la causa russa, ma anche a distruggere la fiducia nelle nostre istituzioni. Serve più che mai un’Europa unita. Ma, soprattutto, è necessario che i cittadini europei rimangano in piedi. E questo significa non essere pigri nella critica (uso della ragione), sapere di chi possiamo fidarci e di chi no, non accettare la manipolazione dei nostri affetti, non tollerare che il nostro malessere si trasformi in cinismo o in pulsione distruttiva. Significa continuare a costruire. E a proporsi come protagonisti. Nel legame inscindibile che lega oggi le diverse parti del mondo, e alla luce delle faglie profonde che si stanno muovendo sotto la crosta della globalizzazione, il rischio vero è che la guerra diventi una sorta di stato permanente che conosce momenti più acuti di crisi, in una condizione di conflitto cronico. Ora c’è l’Ucraina. Ma è importante sapere già che non ci saranno vincitori. Mentre si gestisce l’emergenza, occorre lavorare a un metodo per comporre le tante fratture che spaccano il mondo. È a questo piano superiore, più che all’interesse di parte, che occorre guardare se si vuole cercare di percorrere la via, oggi più che mai difficile e necessaria, della pace. Eppure la guerra si respira più della pace. Ho letto di figli che si rivolgevano, all’improvviso, ai genitori per chiedere… 'Papà cosa succede se comincia la guerra?' E di seguito: 'Papà ho paura, anche noi andiamo in guerra?'. Domande che non lasciano respiro. Per due anni abbiamo definito la pandemia una 'guerra', chiamati ad affrontare un virus che, come scrive ancora un piccolino in un tema alle scuole elementari, è un «mostro che non ci fa scambiare merendine e non ci fa alzare dai banchi per aiutare i compagni». E ora una guerra aperta, ad alta intensità, è scoppiata in Europa, violenta e drammatica. Domande che provocano altre domande tra adulti che cercano possibili risposte. Ci siamo forse adagiati sui miti della democrazia e della libertà, che, date spesso per scontate, reclamano invece una continua conquista e la risposta alla coscienza del sangue versato dai nostri nonni, neanche tanto tempo fa. Siamo adulti che dal divano assistono a 'guerre a pezzi' sparse nel mondo? Siamo spettatori, direbbe Bauman, il cui impegno sociale, politico (quando c’è!) «quasi mai va abbastanza oltre da colpire le radici del male»? Di fatto, l’Italia è tra i più importanti Paesi produttori di armi al mondo e il suo Pil sembrerebbe resistere anche grazie a quella che, con linguaggio duro e realista, si definisce industria bellica. Una industria che oggi preme sul governo per l’aggiudicazione di parte dei fondi del Pnrr, questione di cui, in maniera imbarazzante, si sente poco e niente parlare. Le industrie leader nella produzione e nelle forniture militari hanno continuato a fare affari nonostante la crisi economica e la pandemia ancora in corso. Il Papa denuncia che ci sono più armi oggi che durante la 'guerra fredda', ma l’allarme resta inascoltato, e inevasa è la sua richiesta ai governi di affrontare la propria responsabilità nella vendita delle armi. L’«andrà tutto bene» di ieri nel deserto sociale di oggi mostra come inefficace sia ogni intenzione che non sia sostenuta dalla convinzione di tutti e ciascuno ad un’inversione e conversione culturale, spirituale. In questo momento così delicato della nostra storia le domande dei nostri figli sono vitali, l’incapacità di dare risposte più che un fallimento è un monito a fare presto, a fare bene. Di certo quelle domande non vorremmo mai ascoltarle, ma la realtà va guardata in faccia e la realtà oggi è che la guerra è tra le paure dei nostri figli, peggio del buio della notte in cui una mano sul viso basta a rasserenarli. Poi ancora una domanda: 'Papà, ma non possono parlarsi?'. La disarmante semplicità delle domande dei bambini alla quale corrisponde la complessità di risposte che si traducono, spesso, in imbarazzante silenzio. E su una cosa non si può mentire: siamo tutti in guerra, siamo tutti complici di vite spezzate, città distrutte seppur a migliaia di chilometri distanza. Questo va spiegato con forza. Non basta più commuoversi, ma bisogna muoversi. Bisogna compiere gesti personali di preghiera e di partecipazione, come è stato fatto il 2 marzo – Mercoledì delle Ceneri per la Chiesa – accogliendo l’invito del Papa al digiuno. Perché la paura non si trasformi in angoscia e i nostri figli non restino come noi spettatori. Non possiamo lasciare ancora a loro il compito più difficile.
Carlo Cammoranesi