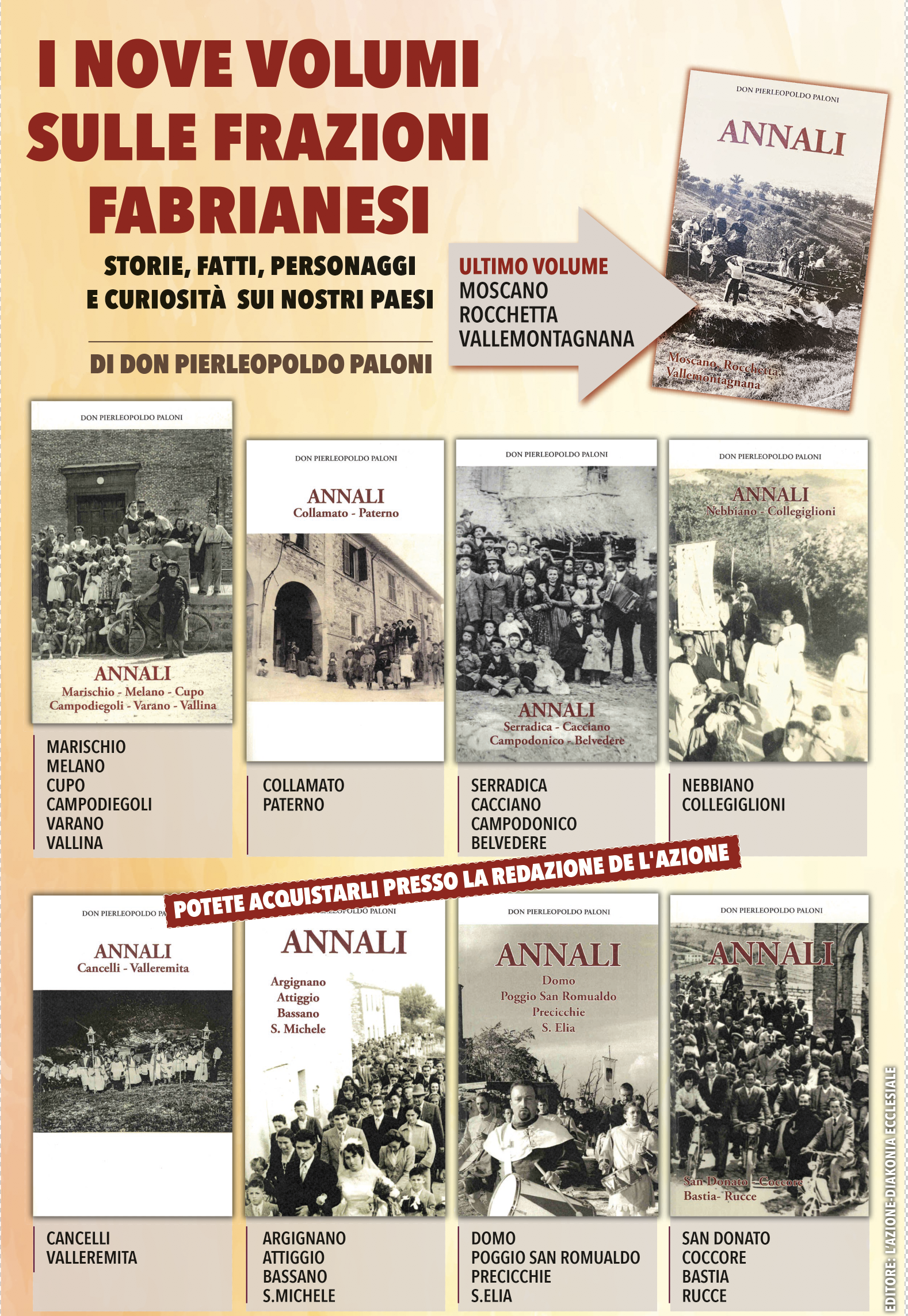Ossessione del futuro
Non è la carta igienica, non è la farina per fare il pane in casa e neppure il gel igienizzante. Il prodotto principe di questa pandemia e dell’isolamento sono le previsioni, la descrizione del futuro. Quando scorgiamo le foto delle città senza auto e piene di gente che corre o passeggia, persone in cerca di libertà al primo sole di maggio, cominciamo a immaginare il mondo-che-verrà. Consumiamo futuro perché non possiamo smettere di progettare, perché l’istante è diventato troppo incerto e convulso. La predizione vuole costruire il domani con il materiale con il quale crediamo sia fatto il presente. Molte predizioni sono fatte con un’analisi astratte, poche con la vita concreta che abbiamo nelle nostre mani. Forse per questo continuiamo a pensare il mondo-del-dopo come una raccolta di propositi etici. Dopo lo stress post-traumatico, un maggior impegno nei lavori domestici, una vita più modesta, più attenta alla sostenibilità del pianeta, più capace di prescindere dal superficiale, più centrata sulla vicinanza, più resiliente, senza unghie artificiali, senza viaggi per il mondo per farsi selfie senza ricordare dove eravamo stati. È possibile che questi cambiamenti si verifichino, benché ci sia poco da sperare negli automatismi della condotta collettiva. I propositi sono fonte più di frustrazione che di creazione. In realtà, prima della severa crisi economica che stiamo cominciando a soffrire, dell’aumento del debito, della ridefinizione della globalizzazione, delle tensioni tra libertà e sicurezza, della tentazione del sovranismo e della sfida dell’innovazione (educativa e produttiva), ciò che conta è quanto ci siamo resi conto della sostanza di cui siamo fatti. Questa sostanza si rivela nelle relazioni: con gli altri, con noi stessi e con il mondo. Noi gente dei Paesi ricchi lavoreremo di più con il telelavoro e ricorreremo di più alla telemedicina. Ma la cosa decisiva è come ci concepiamo, cosa tutt’altro che teorica. È inevitabile una ridefinizione della globalizzazione, con una riduzione del commercio mondiale. Probabilmente assisteremo a un cambiamento nelle catene di approvvigionamento, più organizzate per regioni che a livello mondiale. Ci saranno restrizioni nazionali e regionali su alcuni beni considerati strategici. La globalizzazione che abbiamo avuto finora, nella quale il mondo asiatico stava prendendo il sopravvento, aveva dato per scontato che la libertà di circolazione, di persone e di capitali, accompagnata da alcuni valori occidentali, fosse sufficiente per tener il mondo collegato. Non c’era una globalizzazione dell’umano, un confronto sulla esperienza che dà significato in ogni cultura. Senza questo confronto, la ristrutturazione dei mercati per regioni non porta a un cambiamento sostanziale. Questa coscienza è anche un antidoto per il sovranismo di quelli che vogliono fuggire dal collasso, rende possibile il realismo di riconoscere che senza l’Unione europea (malgrado la sua ottusa reazione iniziale, le pressioni contro il Sud di paradisi fiscali come l’Olanda) la “mistica delle frontiere” ci condanna alla povertà. Un termine che viene spesso messo a tema da Papa Francesco, non come una litania insopportabile, ma come memoria di uno sguardo. Povertà. Ecco il dopo, un altro, spaventoso orizzonte. Parla spesso di fame nel mondo, ma questa volta lo fa in un’accezione nuova. Come conseguenza della pandemia: «Si incomincia a vedere gente che ha fame perché non può lavorare, non aveva un lavoro fisso, e per tante circostanze. Incominciamo già a vedere il "dopo", che verrà più tardi, ma incomincia adesso». Nuova fame di nuovi poveri, che fino a ieri se la cavavano, precari, lavoratori in nero o confinati nella sempre più grande zona grigia del lavoro povero, ma anche dipendenti licenziati. Una folla appiedata di colpo, che da un giorno all’altro non porta a casa niente. Gente che la fame vera non l’ha mai vista, ed è attonita, e si vergogna, a domandare. Chiesa, Caritas, Banco Alimentare e tutto il volontariato italiano, come registra da settimane questo giornale, si stanno dando da fare con tutte le loro forze accanto alla Protezione Civile per l’incipiente emergenza. Ma l’epidemia paralizza le città, ed è difficile anche riconoscere e raggiungere chi ha bisogno. Nuovi poveri che mai prima hanno chiesto un aiuto, e non hanno il coraggio di farlo, o non sanno come. Uno scenario che sta tremendamente a cuore al Papa e lo si intercetta in tante espressioni, gesti, segni. Uno dice: sempre quello. Ma è di una potenza capitale, unico, che resta nel tempo. Sì, quella sera del 27 marzo, nella vastità del Colonnato deserto, saliva verso la Basilica vaticana a pregare per il mondo intero. Il cielo cominciava a imbrunire, e su Roma cadeva una pioggia intensa. Tempesta e buio: straordinariamente, come nel Vangelo di Marco che il Papa aveva scelto di leggere. «Venuta la sera», inizia quel passo. Sì, è calata d’improvviso, un buio di cui la nostra generazione, tranne i più vecchi, non ha memoria. Soffrono e muoiono in tanti. Sono caduti a decine medici, infermieri, sacerdoti, anziani negli ospizi. Le bare esuli sui camion dell’esercito da Bergamo, dove sono troppe per seppellirle, sono la tragica istantanea dei giorni passati. Ma un’altra tempesta incombe, quella delle mani vuote e dei piatti vuoti. A tutti è chiesto di capire, questo ci dice il Papa, che cosa è necessario e cosa è superfluo. Almeno il superfluo, lo si può donare. È allora il tempo di guardarsi tutti attorno, e aiutare. In fretta: la straordinaria solidarietà sta dispiegando la sua forza, ma è urgente lo sguardo su chi ci vive vicino. La fame, ha fretta. E non lasciamo che l’angoscia per contagio e morte e disoccupazione ci sommerga. «Perché avete paura?», domanda Cristo, sulla barca di Pietro che beccheggia. Perché avete paura? Questa domanda Francesco ce l’ha ripetuta ben cinque volte. «Non avete ancora fede?», chiede ancora Gesù ai discepoli spaventati. Il nodo, ha detto il Papa, è imparare a «fidarsi di Cristo». Lasciando che le nostre precedenti certezze rovinino, lasciando anche che la tempesta ci percuota. Ma sapendo che «con Lui a bordo, non si fa naufragio. Perché questa è la forza di Dio: volgere al bene tutto quello che ci capita, anche le cose brutte». Come i temporali che in quel venerdì di un’inimmaginabile Quaresima sferzava Roma. Che lasciano, all’alba, un cielo terso e un’aria nuova – un’aria rinata. E che per il dopo Covid, perché tanto arriverà, ci fa sentire meno soli e più protetti.