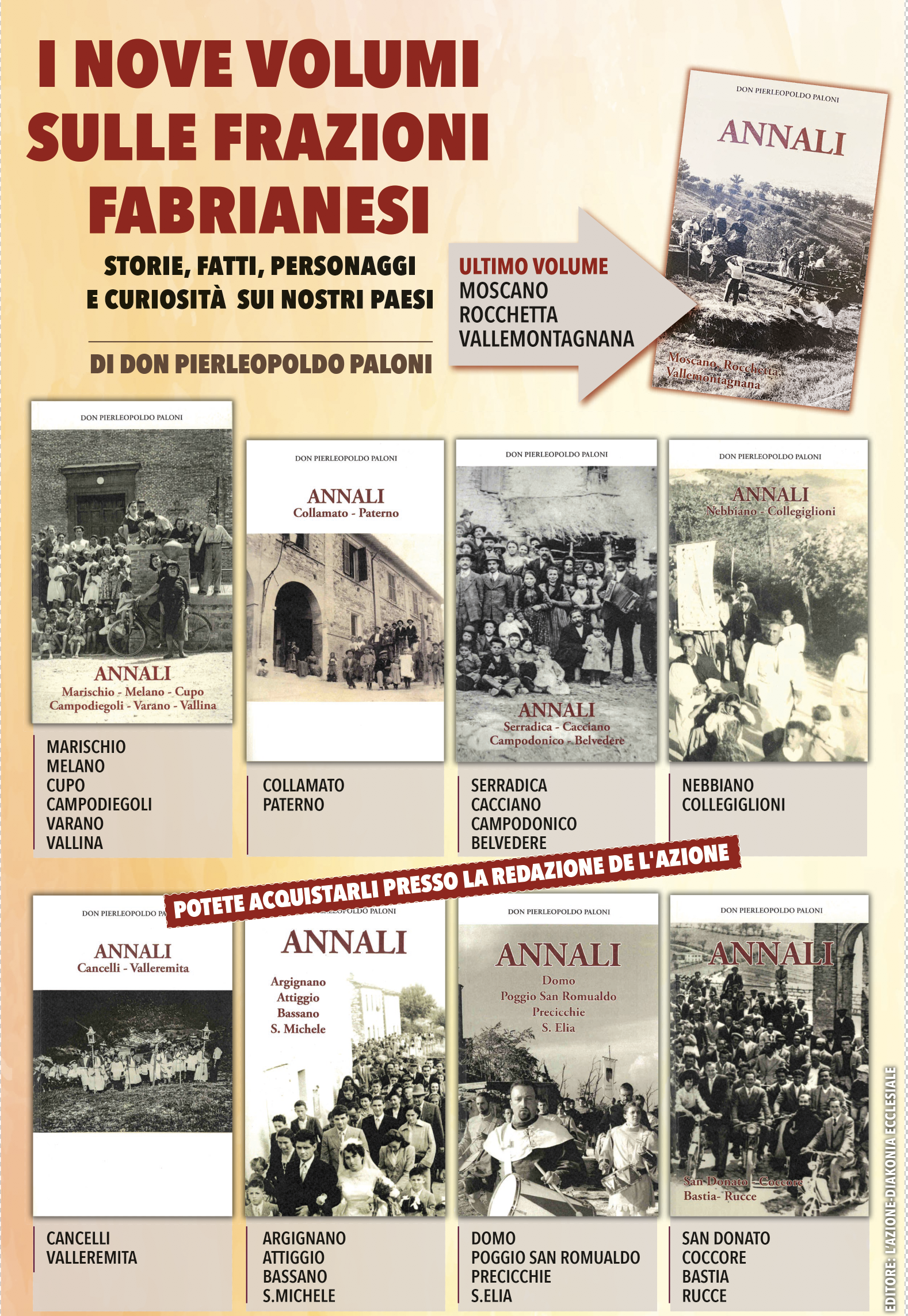Visitare i cimiteri: perché?
capire che a novembre, mese dei defunti, riscopriamo improvvisamente il bisogno di ricordare i nostri cari, chi non c’è più. Il corteo di auto che in molte città cerca parcheggio sotto l’acqua scrosciante sta lasciando intendere che anche quest’anno i cimiteri sono meta di un sobrio pellegrinaggio degli affetti e dei ricordi, in questi giorni di metà autunno in cui la società si ferma per lasciare spazio alla memoria e al rispetto di chi non è più al nostro fianco. La morte è da sempre l’argomento più difficile della vita. E spesso è rimosso. Accettare che le cose finiscano, che la vita abbia un termine, significa implicitamente ammettere di non possedere alcunché, ma di aver ricevuto tutto “in prestito”: un giorno dovremo restituire genitori, nonni, figli, amici, colleghi di lavoro, mariti e mogli. Il tempo passato con ciascuna di queste figure è un tempo della vita, non tutta la vita. Ma avevamo un sostegno, uno spazio di felice prospettiva. Perché, benchè derisa dal mondo moderno, quello occidentale in particolare, la fede o quanto meno la speranza nell’aldilà è stata per millenni il motore della storia. Chi ha costruito le cattedrali medievali che oggi andiamo ad ammirare con lo smartphone sapeva che non avrebbe veduto il compimento del proprio lavoro, tanto erano infiniti i cantieri: ma credeva in un eterno cui era dedicata tanta fatica. E re, condottieri, navigatori, scienziati e semplici uomini di generazioni e generazioni hanno intrapreso piccole e grandi opere solo perché convinti che tutto avesse un senso che avrebbe vinto il tempo. Ma allora quel tempo si riempie di domande e chiede, con forza crescente, almeno uno scopo, un motivo, un perché. “Se stiamo insieme ci sarà un perché” cantava qualche decennio fa Riccardo Cocciante, ed è l’avventura della scoperta di quel perché che oggi manca, salvo poi trovarci spiazzati da una morte che non ci dà pace per il semplice motivo che non è chiara ai nostri occhi la ragione per cui ci è stata data quella vita. Fa impressione constatare come nella stragrande maggioranza dei casi stiamo insieme per caso, senza chiederci come mai ci siamo incontrati e che cosa il rapporto con te significhi per me e per la mia vita. Non sorprende, dunque, che sempre più spesso la morte cessi di essere un evento che dialoga col nostro cuore, segno di un nuovo cammino e di una nuova strada da intraprendere, ma diventi una tragedia irrazionale da cui – per riprendersi – occorrerebbe solo “dimenticare”. Anestetizzare, cancellare tutto in un colpo. Rendere il dolore indolore, o addirittura annullarlo. Ma un tempo non era così. Questa seconda vita, come veniva chiamata, dipendeva magari da come si aveva vissuto la prima, dai meriti accumulati o dai crimini commessi: e l’aldilà poteva essere dunque un ineffabile premio o una pena eterna. Così abbiamo, dal profondo dei millenni, imparato ad elaborare il lutto e ad ‘addomesticare’ la morte. Il culto dei defunti e la speranza di una futura retribuzione ci aiutavano a fuggire il terrore disperante del nulla, mentre l’atto del morire si configurava come un pur pauroso e doloroso rito di passaggio da una forma di vita alla successiva. Miti e dogmi, parabole e visioni, ci rassicuravano circa il nostro futuro di vita eterna e magari perfino sulla possibilità, per grazia divina o arte magica, di comunicare con i defunti e di influire sul loro destino. La morte diventava così il culmine della vita. Platone insegnava che tutta la vita era una preparazione alla morte; la solennità delle cerimonie funebri e l’onorevole fasto dei sepolcri rendevano familiare e quindi perfino gradita l’idea di un’interruzione dell’imperfetta vita fisica, in quanto certezza di perfetta vita futura. Ma nella nostra civiltà occidentale cominciò inesorabilmente a cambiare qualcosa e man mano che la qualità della vita migliorava e parallelamente diminuivano le certezze religiose, il crescente individualismo insinuava sempre più il dubbio sulla vita eterna fino ad instaurare alfine il suo contrario: l’idea della morte come fine di tutto. Ma non è così, non può essere così. Pellegrinare fra le tombe non è passare in rassegna i lutti e i dolori di un’intera vita, bensì imparare a ringraziare per ogni volto, per ogni passo, che ha reso la nostra vita così vera, così lontana dall’oceano di mestizia che sembra riempire i ricordi di questi giorni. Non perché il lutto sia venuto meno, ma per la straordinaria percezione che ogni addio si è posto nella nostra vita come passo – come opportunità – di accostarci di più ad un abbraccio che in fondo ci attende da sempre. Oggi in che cosa crediamo? Con chi parleremo quando al cimitero ci troviamo a far visita ai nostri cari? A lapidi di pietra? A fantasmi del passato? O a persone che crediamo ancora vive, in un dove e in un come pur inimmaginabili? Questa domanda non ha una risposta. Ma è l’unica davvero decisiva per il nostro destino e averla rimossa non ci rende più sereni. Resta il mistero. Con una certezza, però: che dentro ciascuno di noi c’è qualcosa che urla. E urla per la vita.