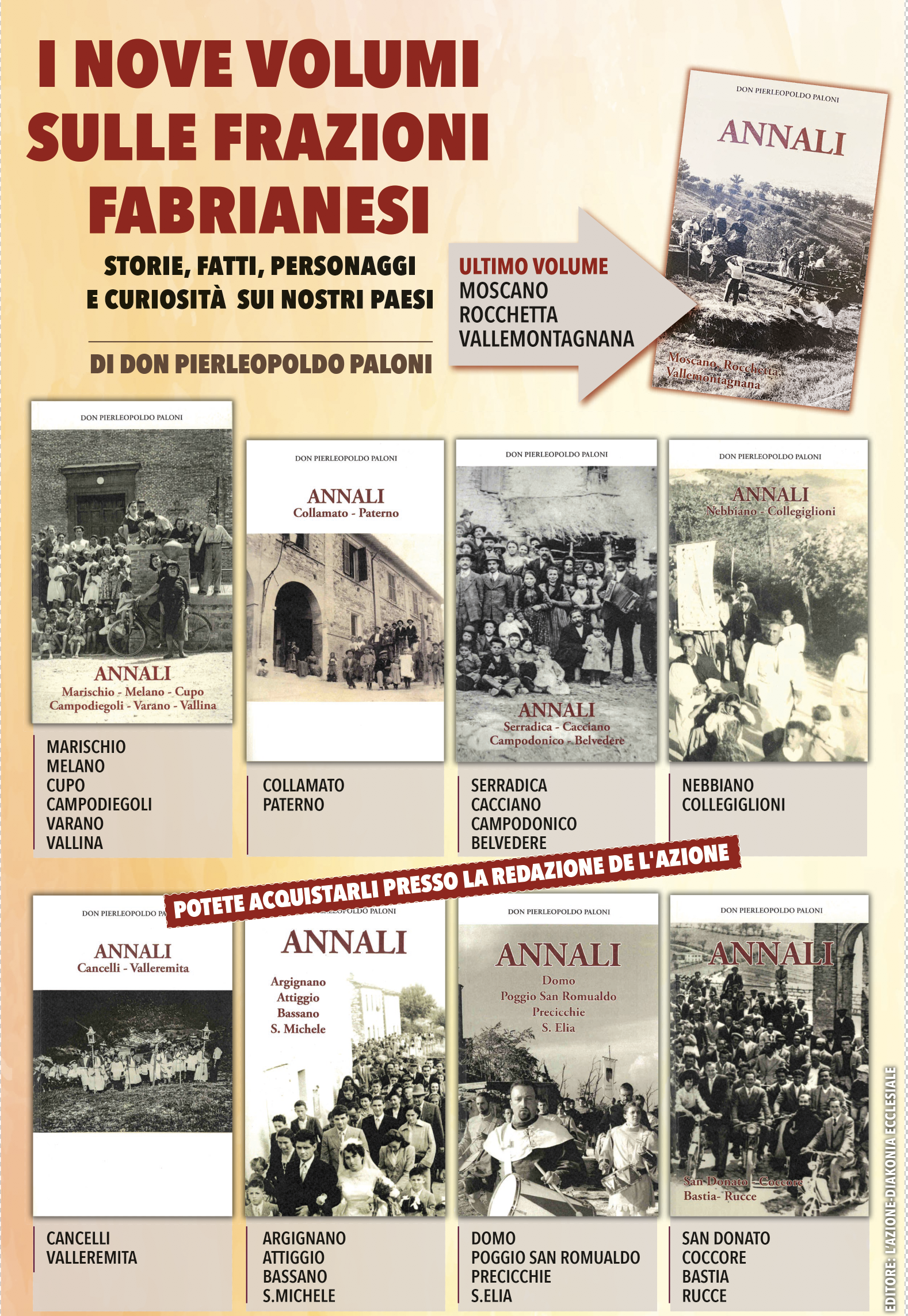Scuola: educazione è altra cosa!
La pandemia è stata la prova più dura della nostra vita, almeno per coloro tra noi che non hanno conosciuto la guerra. L’abbiamo affrontata con molti errori, ora sempre più evidenti: la mancanza iniziale di mascherine e soprattutto di regole chiare, il contagio portato negli ospedali e nelle case di riposo, le zone rosse mancate. Dobbiamo guardare avanti: comincia una nuova fase, irta di incognite. Abbiamo capito che la battaglia sarà lunga. La normalità, o almeno quello che immaginiamo, non è per domani. Conosciamo meglio il virus, però manca ancora una cura universale ed i tempi per il vaccino non sono certi. E’ uno sprint tra potenze ad esibire i propri muscoli, a mettere in vetrina, ma senza una verifica, le proprie capacità umane e tecnologiche: il vaccino ce l’ho prima io e via sbraitando. Ma non sapremo tra quanti mesi sarà disponibile e quanto tempo occorrerà prima che la popolazione sia immunizzata. Regole e procedure, che poco per volta sono diventati la prassi, ci faranno compagnia ancora per molto tempo. Quasi tutti gli italiani hanno compreso che l’apparente limitazione della propria libertà personale era una forma di rispetto per la libertà e la sicurezza altrui. Intanto nei prossimi mesi non serviranno né la distopia, né l’ottimismo. Né il timore della catastrofe, né l’illusione che tanto andrà tutto bene: perché quasi 36mila morti (che fuori dalle statistiche ufficiali saranno molti di più) ci ricordano che non tutto è andato bene. Abbiamo imparato dal dolore e dall’esperienza. Sappiamo che la curva dei contagi, con la cattiva stagione, è destinata a salire. Ma ora la sanità è meglio attrezzata, le mascherine ci sono, così come le regole sono più chiare. Ci saranno di sicuro chiusure parziali, rinunce, difficoltà, ma il popolo italiano ha dimostrato di saper soffrire. Di solito non siamo scattisti e velocisti, piuttosto marciatori e maratoneti. E questa sarà una maratona, che richiede resistenza e serietà, senso pratico e forza morale. La nostra parte la faremo, come sempre. Ma ci vuole che, magari sul fronte politico, fosse la stessa cosa. Apriamo a caso un foglietto dal nostro desk per segnalare qualche emergenza o priorità da affrontare, su cui siamo un passo indietro. E qui non è che c’è da essere velocisti, non siamo nemmeno passisti o maratoneti, appunto. Siamo fermi. Più di una volta abbiamo toccato la questione della scuola e di come ci si limiti esclusivamente a slogan di circostanza o a prese di posizione di facciata, lasciando gattopardescamente tutto come prima. Spesso peggio. Investire nell’istruzione. Già, cosa vuol dire? Nel diritto allo studio? Nella riduzione dell’abbandono scolastico? Nelle retribuzioni degli insegnanti? Nel favorire corsi d’eccellenza, o nella digitalizzazione? In questa giostra di ipotesi, spunta il dubbio, forse legittimo, che il problema principale non sia quello finanziario. Ma probabilmente di chi la scuola la fa e la vive. Come gli insegnanti. La scuola in definitiva è la loro capacità e dedizione, la loro qualità, non i programmi, i laboratori, le attrezzature, l’inclusione. E dunque la crisi dell’istruzione scolastica dipende in larga misura dalla crisi della loro figura e ruolo, dalla fine della loro centralità. Una peculiarità, quella dell’insegnamento, ridotta al tango di un impiegatuccio, cancellata dal dilagante burocratismo cartaceo, dall’affollarsi di compiti e mansioni le più varie collaterali all’insegnamento, ma soprattutto da una pervasiva ideologia che ha fatto della scuola un’istituzione di tipo socio-assistenziale regolata da un democraticismo pseudo-benevolo che si è fatto un punto d’onore nel considerare degli inutili ferrivecchi il merito e la disciplina. Cioè proprio le due dimensioni cruciali in cui si incardina il ruolo dell’insegnante e per riflesso anche la sua autorevolezza sociale: la possibilità grazie all’accertamento non contrattabile del primo e all’amministrazione della seconda di influire in maniera significativa sul futuro dei giovani. Non c’è nessun proposito di trasformare la scuola in un penitenziario. Scartabellando tempo fa, leggevamo l’esempio di un Paese come la Germania dove al termine dei quattro anni della scuola elementare, un alunno non può affatto iscriversi al corso di studi che più gli piace. A raccomandare l’iscrizione a questo o a quel corso, infatti, è la scuola, e dipende dai voti che il bambino ha conseguito. Ad esempio, per potersi iscrivere al Gymnasium, l’equivalente del nostro liceo e via maestra per l’università, bisogna aver riportato nelle materie basiche ameno una votazione corrispondente al nostro 8. Magari sono casi limite, episodi estremi che non trovano… cittadinanza da noi. Riesce qualcuno a raffigurarsi nei termini esatti il prestigio sociale che in un tale sistema finisce per avere l’istruzione, la figura del maestro e dell’insegnante in generale? Si tratta di un prestigio direttamente proporzionale al ruolo in buona parte decisivo che il giudizio della scuola ha, e non esita ad avere, sulla vita dei giovani, sul loro futuro, un giudizio in pratica senza appello per rimediare al quale non esistono le dubbie scappatoie a caro prezzo tipo Cepu, Grandi Scuole e Università telematiche che esistono da noi. Ed è un prestigio direttamente proporzionale al profondo senso di responsabilità e dunque alla serietà con cui la scuola e chi vi lavora sentono di dover assolvere al proprio compito: senza indulgenze pelose, senza farsi scudo dietro la retorica dell’accoglienza. Certamente l’Italia non è la Germania, ma dobbiamo convincerci che la qualità dell’istruzione dipende più che da ogni altra cosa dalla centralità-qualità degli insegnanti e che a sua volta questa finisce per dipendere direttamente dal modello di scuola che si adotta. Negli ultimi decenni abbiamo introdotto una serie di riforme che hanno costruito una scuola in cui i bravi insegnanti ancora esistono, ma dove quella centralità è di fatto messa al bando. Rafforzarla, stimolarla dovrebbe essere oggi il primo compito delle istituzioni se non si vuole che queste ultime inizino a svolgere la parte di un virtuale curatore fallimentare. La scuola non può quindi porsi solo come luogo fisico e frequentabile dell’apprendimento, ma anche della crescita delle persone. Non è solo mascherine e banchi monoposto, ma è anche qualcosa di cui nessuno parla, forse perché inconsciamente si ammette che non esiste più un senso condiviso da tutti su cosa sia educare: e quindi, se è solo una trasmissione di conoscenze, allora è logico che si parli solo di beghe organizzative. Pare che nessuno, o comunque pochi, senta il problema educativo di fondo: quello di dare una unitarietà, una continuità, all’educazione. Il Covid ha messo in evidenza non solo alcune criticità ma anche alcune positività che, se sfruttate, avrebbero potuto imprimere un nuovo corso alla scuola. Alludiamo alla scoperta che non sempre è così necessaria la presenza per trasmettere una conoscenza, il de visu non è così necessario per l’informazione, tanto è vero che adesso si parla di didattica integrata più che di didattica a distanza. Così però, emerge ancora di più la domanda: se possiamo veicolare la conoscenza attraverso una lezione su YouTube, quando il docente è in classe cosa fa, cosa dice, qual è la novità dello stare lì dell’insegnante? C’è un saper fare, un saper essere che si può dare solo “in presenza”, e lì casca l’asino. E tutto ciò è lasciato alla libera esigenza percepita dall’insegnante. Non esiste nessun piano scolastico che enunci tra gli obiettivi prioritari della classe il “crescere nell’essere”. Peccato dunque perché stiamo perdendo l’occasione di colmare una lacuna che il Covid ci aveva mostrato. Oltre alla trasmissione del sapere c’è l’esigenza di una trasmissione dell’essere: invece no, ci fermiamo alle mascherine o al banco monoposto.