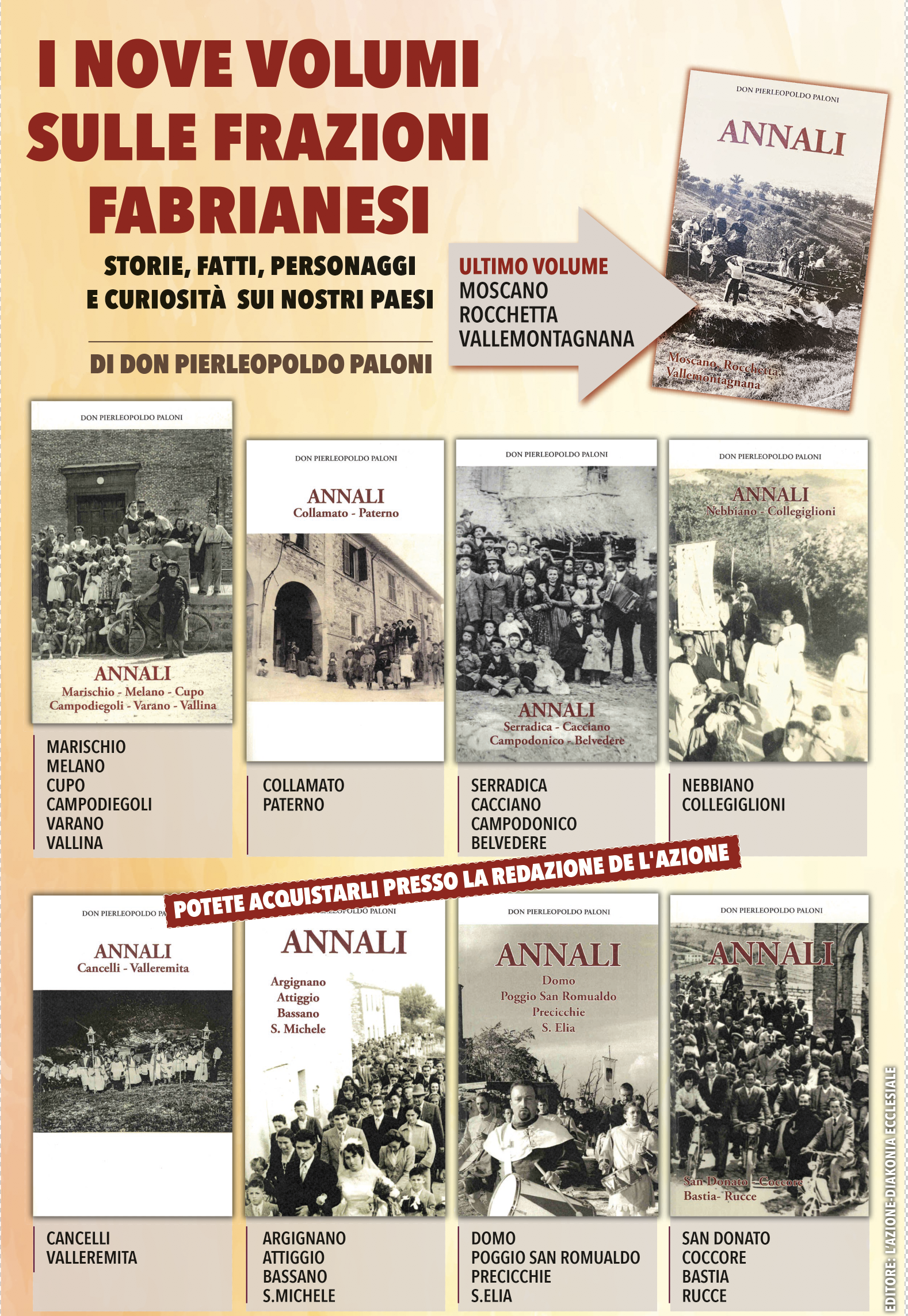La fame di eterno
Perché meravigliarsi di una lettera di un Vescovo rivolta ai propri sacerdoti? E perché tutto questo trambusto mediatico? Quando semplicemente il presule di Reggio Emilia-Guastalla, Massimo Camisasca non ha fatto altro che preoccuparsi della vita del popolo e non solo della sua salute, visto che di questi tempi tutto è emergenza e allarme e risuonano parole marziali come “coprifuoco” ed altre espressioni apocalittiche. C’è la forte preoccupazione di un pastore che vede il suo gregge «correre il rischio di entrare in una visione paranoica della realtà» e finire per convincersi che «l’unico criterio sia chiudersi in casa». Invece, «senza demordere da tutte le attenzioni dovute, dobbiamo continuare a vivere». È questo – aiutare a vivere pur in mezzo alle difficoltà – il compito della Chiesa e il guadagno del cristianesimo: «Mai come in questo momento è chiaro che le ragioni della fede sono le ragioni della vita». Il pastore della Chiesa chiede dunque di sostenere la fede, la speranza e la carità del popolo, del nostro popolo. Dopo il lockdown tante sono state le persone segnate dal disagio psicologico, più ancora che dalla malattia e dalla povertà. Così in qualche caso si sono ingigantiti anche problemi relazionali, magari già presenti, perché non sono stati affrontati con la dovuta pacatezza e razionalità. E’ in questo frangente che si inserisce l’invito ad una fede non astratta. “Se la nostra fede è vera, essa è sempre una luce e una forza dentro le difficoltà del momento. Non dobbiamo mai dimenticare che Dio non lascia la nostra mano. Dio permette le difficoltà perché noi abbiamo a riscoprire la concretezza della Sua presenza e la necessità della nostra conversione”. Eppure la pandemia si è abbattuta sull’Italia con violenza inaudita, andando a esacerbare alcune situazioni che erano già vicine al collasso. Quella più drammatica, epocale, riguarda quel magnifico tessuto di vita e attività umane che per secoli e secoli ha vissuto dentro i nostri paesi e nei loro centri storici. Chi vive nei piccoli e medi centri del nostro Stivale ne è tristemente consapevole. L’Italia, il Paese dei paesi, sta diventando un deserto di serrande chiuse e sogni imprenditoriali che s’infrangono, di vie, corsi interi di negozi serrati dove in bella mostra c’è solo il cartello 'vendesi'. le statistiche del 2020 non sono ancora disponibili, ma saranno paragonabili a quelli di un Paese appena uscito da una guerra. Chi riesce a resistere lo fa in perdita, spesso perché legato a quell’attività da sentimento puro, non certo da guadagno, perché quell’attività è spesso tradizione familiare, inaugurata magari da oltre un secolo. Chiudere la serranda definitivamente significa arrendersi per sempre, tradire il lavoro di chi ha speso una vita intera per quell’attività, che l’ha tirata su dal nulla scommettendo su un sogno. I nostri genitori. I nostri nonni. Viviamo in un Paese che strangola di tasse e burocrazia, che non aiuta, anzi, semmai è zavorra ai progetti di chi malgrado i tempi tenta di scommettere su un negozio. Ma quello che sembra sfuggire ai più è però altro. La valenza sociale, collettiva, delle piccole e medie attività che fiorivano nei nostri centri, che ne erano in qualche modo anima e motivo di aggregazione. Senza mercato a dimensione umana viene meno il concetto stesso di polis. Perché questo era il motivo per cui si andava in paese: per acquistare beni di prima necessità, o il vestito buono per la domenica. Senza negozi la polis sparisce. Basta girare da nord a sud il nostro Paese. Perché a serrande abbassate corrisponde il più delle volte lo spopolamento dei piccoli centri. Cosa si rimane a fare in un luogo che non ha più nemmeno un forno per comprare il pane? C’è dunque un male strisciante che si sta impossessando di tutto il mondo. Non è l’obesità, nemmeno il suo atroce contrario: la fame. Né l’alcolismo. Né le molte altre piaghe antiche o recenti che affliggono l’umanità. La malattia che si sta impossessando del genere umano è la depressione. Sono molte le motivazioni tirate in ballo per spiegare l’invisibile e silenziosa esplosione di questo morbo, spesso letale più del Covid, a partire dai ritmi frenetici del nostro vivere, il rapporto via via più morboso con la tecnologia, rete in testa, sino all’utilizzo smodato di sostanze psicotrope, una via privilegiata per far entrare nella nostra vita questa terribile malattia. Alcuni temi centrali della vita sono spariti dai nostri discorsi, gli interrogativi che da sempre hanno accompagnato la vita dell’uomo non sono più leciti. Dio. Morte. Eternità. L’uomo non può non interrogarsi sul suo destino. Il fatto che non lo possa condividere liberamente con i suoi simili non vuol dire togliere dalla sua mente e dal suo cuore la questione. Il risultato di questo imbarbarimento è la solitudine. L’uomo contemporaneo vive gli interrogativi di sempre solo con se stesso, quasi vergognandosene, pensando che sia l’unico al mondo a ritrovarsi con quelle domande impossibili da esaudire piantate al centro del petto. Dalla solitudine alla nevrotizzazione, il passo è breve. E allora? Restituire all’uomo la possibilità di parlare della sua essenza, sin da bambino. Fare dei nostri limiti terreno d’incontro, dialogo e scambio. Senza sensi di colpa, senza paure. Tornare alle domande che ci abitano da sempre, alzare il nostro sguardo fino a Dio, il grande assente, più del vaccino. Non si avverte la ferita della sua mancanza. E pare assente anche del tutto l’idea che la vita debba meritarsi l’eternità, non un mese in più in terapia intensiva. I riti sospesi per mesi, un ritorno blando agli stessi, un vecchio Pontefice che si affida al buon senso di dire che “siamo sulla stessa barca”, il timore di molti preti di apparire untori, hanno quasi silenziato Dio e il grido verso l’eterno, proprio nel momento in cui dilaga il timore della morte. E ci meravigliamo se qualcuno rispolvera la parola speranza e la toglie dal fodero come una durlindana… di pace, non di violenza. Una pandemia dove tutti parlano e dove l’unica voce assente è di chi, di fronte ad uno scenario di morte, richiami la fame di eterno della vita umana. Quella fame che ci abita e per cui, appunto, sentiamo il limite come doloroso non ha nulla a che fare con quello che stiamo vivendo? Non è proprio lei, la morte lì a destare magari come rabbia o supplica, la fame di eterno che ci abita. E che ha movimentato al più alto grado le culture del mondo, capolavori che vanno dalle tragedie ai miti e alla grande epica greca, da Virgilio ai contemporanei, senza tralasciare il celebratissimo Dante. Cosa servono tutti gli sfarzi per i 700 anni del poeta se poi si censura il motore che lo mosse, la fame dell’eterno dinanzi allo scandalo dalla morte. Senza questa fame non siamo uomini, né tanto meno italiani. E siamo più deboli, non più forti davanti all’epidemia.