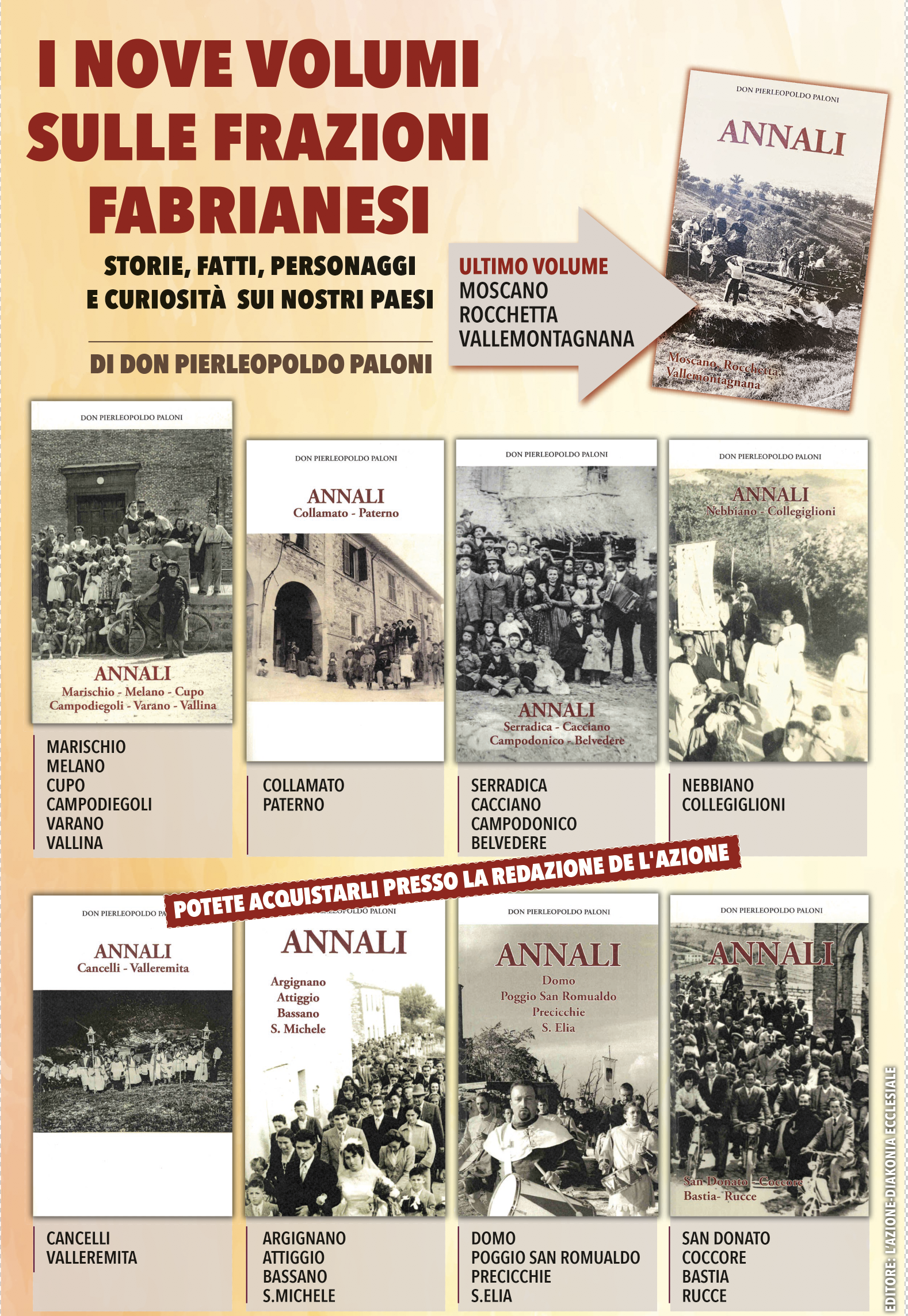Schiavi della...correttezza
Tutto oggi è diventato politicamente scorretto. Non sappiamo più cosa pronunciare o scrivere con il rischio di cadere nelle trappole di una società che stabilisce paletti ed impone canoni dialettici, tanto che si arriva a mistificare una realtà sacrosanta. La riflessione sul politically correct sorge spontanea: la corrente di pensiero che modifica il linguaggio ma non la sostanza, tanto che in nome di un fittizio rispetto bisogna trovare un nuovo nome a posizioni lavorative come il netturbino o il bidello (rispettivamente modificati in “operatore ecologico” e “collaboratore scolastico”), mentre per quanto riguarda retribuzione e tutele lavorative possiamo senza dubbio soprassedere. Un atteggiamento, con tutta evidenza, ipocrita. Ma attenzione, perché usare il termine “ipocrita” per definire qualcosa, sia esso un individuo o un comportamento, è già assimilabile ad un’offesa, e quindi portatore di un possibile turbamento. Ed è questa la reale riflessione che andrebbe fatta sul politically correct, che altro non è in questi termini che censura. Censura di tutto ciò che può turbare. Chiunque. E, quindi, su cosa riflettere? Sull’evidenza che qualsiasi cosa potrebbe causare turbamento e che questa tendenza di ragionamento porta ad innumerevoli fraintendimenti ipocriti. Tutto ciò che è stato fatto, pensato e scritto in passato viene “ricontrollato” nell’estrema ricerca della correttezza formale, passato attraverso i filtri del razzismo e del sessismo e condannato a posteriori. Si cambia nome alle vie, si imbrattano monumenti e lapidi, si abbattono statue, si tolgono dal commercio libri e film, si cambiano i finali delle opere, in una corsa delirante alla correttezza. E’ vietato alla scrittrice bianca tradurre la poetessa nera perché non può comprendere lo spirito black. E’ vietato a Scarlett Johansson interpretare un personaggio transessuale perché lei è cisgender etero. E’ vietato mettere in scena “l’Aida” perché è colonialista e sessista. E’ vietato proiettare “Dumbo” e “Gli Aristogatti” perché fanno discriminazione etnica. E’ vietato chiamare direttore d’orchestra una donna perché rinnega lo specifico femminile, anche se sale sul podio con tacco 12 e abito rosso fiamma. Ma questo pseudo rispetto non è forse diventato eccesso o addirittura patologia? Mi ha fatto sorridere ascoltare un amico insegnante che parlava di un gemellaggio della sua scuola con un liceo russo. “Ci hanno regalato – ha detto – un orso siberiano imbalsamato, alto quasi tre metri, e volevo mostrarlo ai bambini delle elementari. Dieci classi in totale. Un attimo prima una professoressa mi aveva avvertito… se dici che l’animale è stato ammazzato, un gruppo di mamme ti denuncia al Wwf e ambientalisti. Non vogliono che i figli patiscano uno choc”. Com’è finita? Che il prof ha spiegato alla scolaresca che in Siberia fa tanto freddo e che l’orso era morto di polmonite. Ma il giorno dopo, chiedendo la loro impressione, i ragazzi in coro dissero tranquillamente che l’orso era stato ucciso da un cacciatore, altro che polmonite. Morale: il cervello dei piccoli funziona davvero, forse più di quello di certi adulti, tesi invece a mistificare, a confondere, a sparigliare per un farlocco senso di tolleranza e parità. Ma se la cultura rinnega se stessa, le radici, le tradizioni, allora non è più cultura. Tutto e il contrario di tutto diventa sciaguratamente possibile. Senza memoria delle proprie radici, non ci può essere alcun futuro. E senza conoscere ciò che ha forgiato la nostra identità, non possiamo conoscere l’altro, se non riportandolo all’uniformità dell’identico, e dunque misconoscendolo, senza possibilità alcuna di comprenderlo. La comprensione nasce dalla differenza ed è proprio quest’ultima che l’attuale sistema di potere globale cerca di annullare, riducendo tutto a un’unica dimensione livellante e fintamente egualitaria. L’amatissimo Totò paragonava la morte a una livella, perché ci fa tutti uguali. La stessa cosa possiamo dire della mortifera strategia del politically correct, che come una livella normalizza asetticamente ogni forma di dissenso, ogni possibilità di voce altra, riducendola al silenzio, alla non-esistenza. È questa oggi la vera tragedia! Ci sono le priorità – quelle autentiche - e poi ci sono le priorità politically correct. Che, ça va sans dire, sono un farneticante libro degli incubi che un tempo avrebbe meritato ai suoi autori una camicia di forza. Oggi, però, viviamo in una società al contrario. Una società in cui, come aveva profetizzato lo scrittore inglese Chesterton, bisogna sguainare le spade “per dimostrare che le foglie sono verdi in estate”. Perché è ovvio che, di fronte a queste “bazzecole” legate alla pandemia, al Recovery Fund, ai ristori e ai vaccini, le questioni vere sono i nomi che uno storico pastificio sceglie per i suoi prodotti. O il fatto che film girati 50 o più anni fa, come Grease, dovrebbero riflettere la sensibilità degli spettatori di oggi. Amenità, quest’ultima, che ha esasperato perfino certi pseudo-intellettuali de noantri, segno che la pazienza sta davvero finendo. L’aspetto peggiore è che questo non è nemmeno il nadir d’Oltreoceano, di cui può fregiarsi Nancy Pelosi, speaker della Camera. La quale si è messa in testa di abolire termini come “padre” e “madre”, o pronomi come “lui” e “lei”, che avrebbero la colpa di non essere abbastanza inclusivi. Pare quasi di risentire Peppone che sbraita contro don Camillo per via dell’orologio del popolo. «Se è in ritardo sul popolo, tanto peggio per il Sole e tutto il suo sistema!» Peccato che natura e biologia non facciano sconti. E, come recita un aforisma attribuito a Platone, “nessuno è più odiato di chi dice la verità”. Questa espressione, politically correct, è nata negli anni ’70, dagli ex sessantottini, e si incentrava sul tipo di linguaggio da utilizzare per garantire il rispetto verso persone appartenenti a minoranze, a differenti culture, con situazioni di disabilità, di esclusione sociale o di maggiore debolezza nel potere contrattuale e nell’immagine. Il linguaggio voleva rappresentare un atteggiamento di accettazione e di inclusione da parte dei “politicamente corretti” per sancire una alleanza politica con le diverse minoranze. L’accettazione della minoranza è però solo formale e linguistica. Si modifica il linguaggio, ma non i diritti civili. Si difendono ideali stereotipati, ma non cambiano le forme di interazione sociale. Davvero correggere “Gesù Bambino” in “Perù Bambino”, come accaduto in una scuola primaria friulana, è un modo per non offendere bimbi e famiglie di altri credi? Davvero censurare forme d’arte, ci farà dormire sonni tranquilli? Il primo esempio di politicamente corretto lo si trova nella religione cristiana, nello specifico nella questione Barabba, che vede innanzitutto una strumentalizzazione del popolo, della democrazia e, dulcis in fundo, delle parole. Giovanni Papini scriveva: «Barabba è l’uomo, l’uomo per eccellenza che ha salva la vita ad opera di Cristo e non sa perché». Il brigante liberato al posto di Gesù è cioè l’emblema del mondo moderno, che deve gli aspetti migliori della sua cultura, i valori fondanti della propria esistenza e convivenza e la sua stessa vita a un certo uomo storico, in cui però non crede. Barabba non riesce a credere perché non può sopportare che per guadagnare la vita si debba passare dal sacrificio delle proprie idee. E quindi anche trasformare le parole in fatti e azioni concrete. Il politicamente corretto fabbrica pregiudizi seriali: la loro applicazione esime dal ragionare, risparmia la fatica del giudizio critico. E infonde a chi lo usa una sensazione di benessere etico, una presunzione di superiorità sugli altri. Ed è qui che si crea l’assenza di alternative, la mancata elaborazione di strategie, culture e linguaggi, il silenzio e la rassegnazione. Nel frattempo non sapremo più mettere due parole messe insieme per parlare e per scrivere…