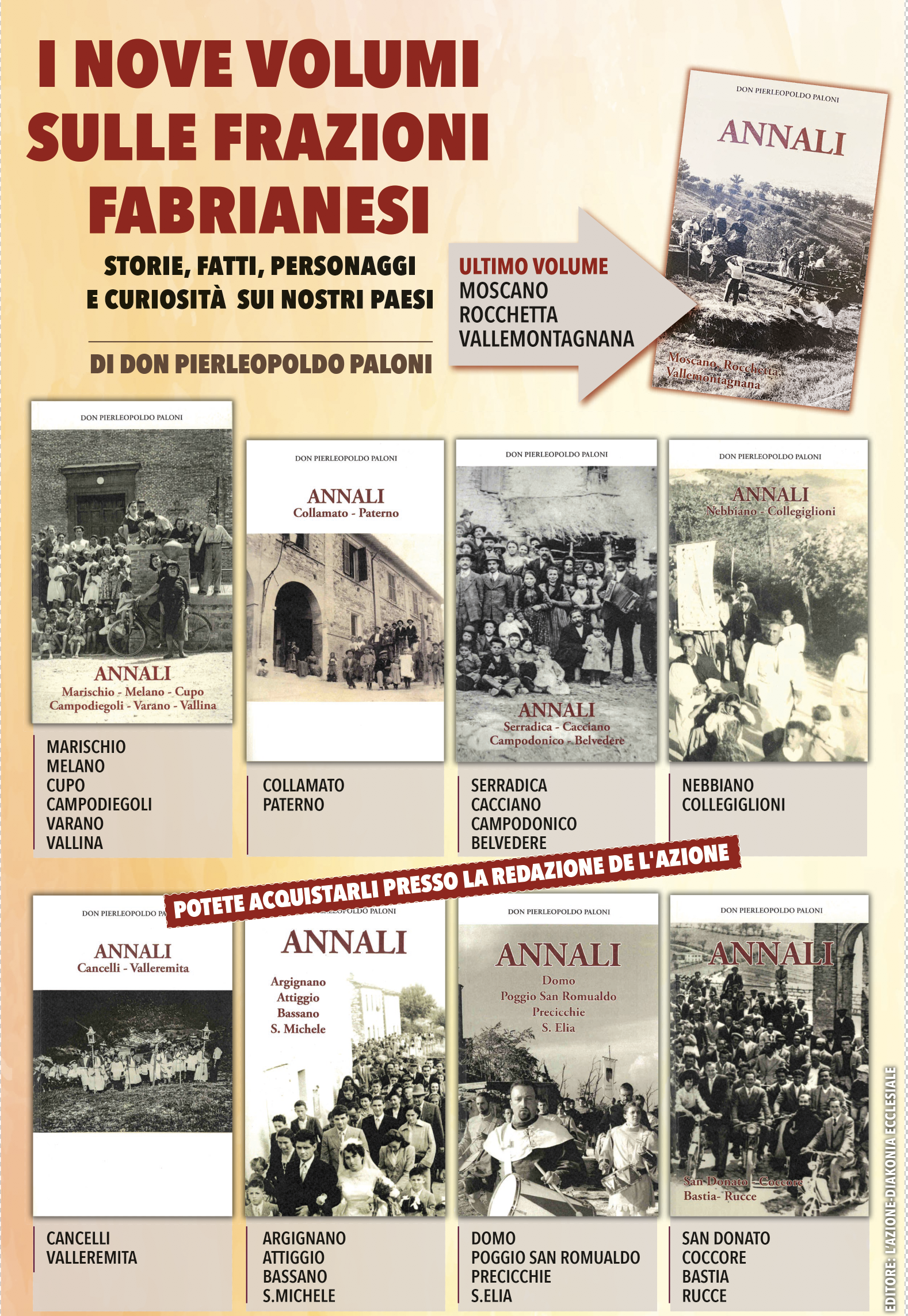La chimera del bene comune
Esiste una amicizia naturale tra l’Italia e il bene comune, questa espressione che sentiamo risuonare, che sta nel cuore della Dottrina sociale della Chiesa come ha richiamato tempo fa anche il Cardinale Bassetti, ma che tanti magari fanno fatica a intendere. Ma questa amicizia naturale tra l’Italia e il bene comune c’è davvero. Siamo la patria di Tommaso d’Aquino, e siamo anche la terra della tradizione della “Pubblica felicità”, il nome che l’economia moderna prese in Italia nel Settecento. Mentre gli americani avevano messo al centro del loro umanesimo il diritto individuale alla “Ricerca della felicità” e gli inglesi sceglievano “La ricchezza delle nazioni”, noi italiani mettevamo al centro del programma della modernità la natura pubblica della felicità. In quella espressione ci sono tante cose preziose, oggi più attuali di ieri. Innanzitutto, essa ci dice che la dimensione più importante della nostra felicità è un qualcosa di pubblico, di condiviso, da cui dipendono anche i suoi aspetti individuali. Quando viene minacciata la pace o si incrina la concordia civile, anche le ordinarie private felicità di ciascuno di noi entrano in crisi e si abbuiano – lo stiamo vedendo in questi giorni. Per conservare e custodire un bene comune, invece, tra le persone deve scattare una logica diversa, che qualcuno chiama “logica del noi”, e così far diventare quel “bene di nessuno” un “bene di tutti”. Salviamo i beni comuni e il bene comune quando riusciamo a vedere un valore più grande degli interessi privati, e una volta che abbiano visto riusciamo a decidere di fermarci, per esempio a fermarci prima che l’erba del pascolo finisca. Ma – e sta qui il problema – durante le crisi è proprio la consapevolezza del “noi” che scompare, perché gli “io” diventano talmente ipertrofici da impedire di vedere il “noi”. Così l’erba del pascolo finisce, tutti stanno peggio, e non resta nulla per nessuno, né per oggi né per domani. E non si torna indietro (è molto difficile ricostituire un bene comune), perché si sono distrutte le relazioni di fiducia su cui si basava il buon uso di quel bene comune. Il bene comune, ancora più radicalmente dei beni comuni, è un bene fatto di rapporti, è una forma speciale di bene relazionale, perché sono le relazioni tra le persone a costituire il bene. Nel bene comune non accade come nelle merci, dove anche se litighiamo con il fornaio possiamo sempre mangiare quel pane che ci ha venduto. Perché quando si spezzano le relazioni, non resta più niente da “mangiare”, e il bene comune si trasforma in male comune. Come succede nell’amicizia e in famiglia: quando si litiga durante la cena, passa l’appetito e si chiude lo stomaco. Peppone e Don Camillo sono un vero mito fondativo del nostro Paese, perché la concorrenza politica tra di loro era fondata su una concordia civile più profonda. Erano diversissimi, ma prima, e a un livello più vero, erano uguali, perché erano cittadini, perché erano umani. E così bisticciavano, si sfottevano, ma poi andavano insieme a difendere Brescello quando il grande fiume rischiava di esondare. Le comunità e gli Stati capaci di futuro sono quelli dove si è stati capaci di coltivare e custodire una amicizia civile che fonda e sostiene le competizioni economiche e politiche, quell’amicizia civile che l’illuminismo ha voluto chiamare fraternità. Quando l’amicizia civile si spezza, i popoli declinano, e si resta in balìa dei grandi fiumi della finanza e dei poteri forti. Le generazioni passate erano più capaci di vedere le ragioni del “noi” sottostanti a quelle degli “io”, anche per le esperienze ancora molto vive dei grandi dolori generati dall’assolutizzazione degli interessi di parte. Noi dobbiamo reimparare, e farlo presto, a vedere il Bene comune e le sue ragioni diverse. Il saper ascoltare, il riconoscere le ragioni dell’altro, il saper rinunciare a qualcosa di sé pur di arrivare ad un accordo non sono solo norme di buona educazione. Sono al contrario la vera, forse la sola strategia che può adottare un Paese in difficoltà. Abbiamo passato momenti ben peggiori, come il secondo dopoguerra, l’età del terrorismo. Due partiti dominavano la scena: la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista. Avevano due visioni contrapposte del mondo e perfino dell’umanità. Eppure sulle macerie dei bombardamenti, nel, ’46, scrissero insieme la Costituzione. E quando negli anni Settanta i brigatisti rossi e i bombaroli. Neri insanguinavano il Paese, nelle piazze le bandiere rosse si mescolavano a quelle bianco-crociate. Perché prima di tutto veniva l’Italia. Uomini come De Gasperi, Togliatti, Moro e Berlinguer si misero insieme, nei momenti difficili, al servizio del bene comune. Ma erano, appunto, De Gasperi, Togliatti, Moro e Berlinguer. Papa Francesco in un’omelia del Te Deum, esprimeva la sua riconoscenza a tutti gli ‘artigiani del bene comune’, che amano la loro città non a parole ma con i fatti. Sono «persone che ogni giorno contribuiscono con piccoli ma preziosi gesti concreti al bene di Roma».?In un discorso di fine anno il presidente Mattarella manifestava fiducia nel futuro, perché «i problemi che abbiamo davanti sono superabili. Possiamo affrontarli con successo, facendo, ciascuno, interamente, la parte propria».?Papa Francesco ha elogiato quanti cercano di compiere al meglio il loro dovere, rispettano i luoghi pubblici e segnalano le cose che non vanno, stanno attenti alle persone anziane o in difficoltà. «Questi e mille altri comportamenti esprimono concretamente l’amore per la città. E cooperano silenziosamente al bene comune». Francesco è convinto che «queste persone, anche se non fanno notizia, sono la maggior parte della gente che vive a Roma».?Il presidente Mattarella ricordando il 70° della Carta Costituzionale, ha precisato che essa «ci sollecita a riconoscerci comunità di vita. Con il suo patrimonio, di valori, di principi, di regole, essa costituisce – citando Aldo Moro – la nostra casa comune».?L’impressione generale è che si confermi un trend in cui perseguire il ‘bene’ è un’impresa sostanzialmente privata non collettiva. L’orizzonte di riferimento rimane lo spazio ristretto dei piccoli interessi e dei risultati immediati. C’è scetticismo – qualcuno lo chiama ‘disincanto’ – verso tutto ciò che è comune, condiviso, partecipe. L’Occidente vive da qualche tempo un clima culturale molto ‘economico’ e poco politico, più competitivo che cooperativo. Parlare di bene e casa comune appare ai più, un’operazione nostalgica e ingenua. Hannah Arendt descrive come ‘tempi bui’ quelli «in cui lo spazio pubblico si oscura e il mondo diventa così incerto che le persone non chiedono più alla politica se non di prestare la dovuta attenzione ai loro interessi vitali e alla loro libertà privata».?Non si tratta solo di analisi o di desideri, ma i due sembrano indicare nel bene comune la sfida più grande dei prossimi anni. Da notare che non si tratta di definire il bene. Si tratta piuttosto di avvertire nell’agire pratico una corrispondenza e una simmetria connaturale tra bene individuale e bene pubblico, tra felicità personale e felicità collettiva.?In sintesi la sfida per cristiani e laici è vivere l’etica della responsabilità collettiva come questione in cui è in gioco la dignità personale. Non ci possiamo accontentare del bene individuale o limitarci al possibile. Perché – chiosando Max Weber – è perfettamente confermato da tutta l’esperienza storica, che il possibile non verrebbe raggiunto se nel mondo non ci fosse qualcuno che ritentasse sempre l’impossibile.