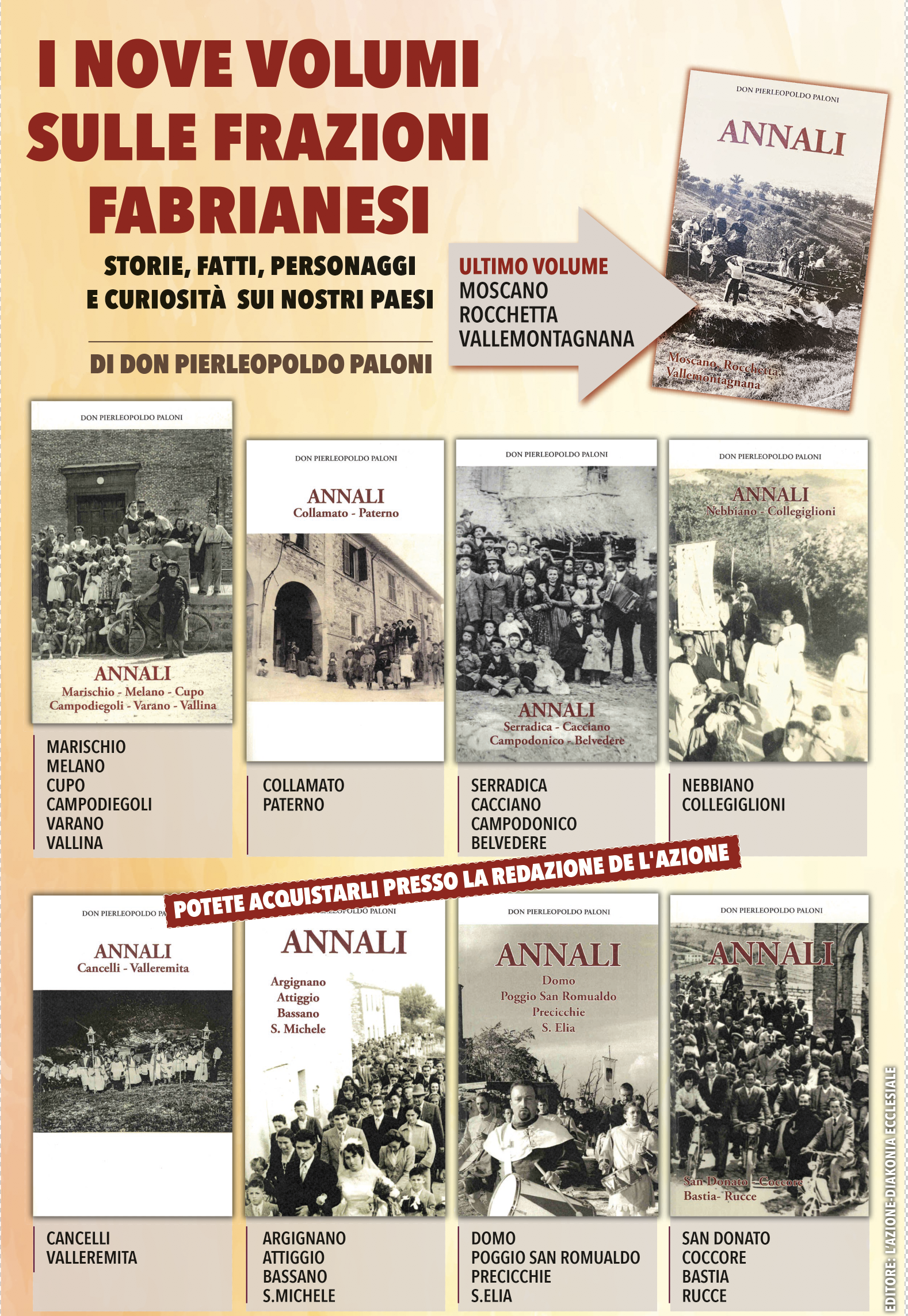Cosa ci insegna l'Afghanistan
La conclusione della vicenda afghana non è soltanto la più disastrosa sconfitta subita in tempi recenti dalla società occidentale ad opera di un movimento totalitario. Segna anche, paradossalmente, il momento di un suo amarissimo successo. I disperati che si aggrappavano agli aerei in volo, le donne terrorizzate dal ritorno dei barbari e tutti coloro che cercano ora di scappare prima che l’inferno li inghiotta, testimoniano che, nonostante vent’anni di guerra e tanti errori, gli occidentali erano riusciti ad aiutare gli afghani a creare, quanto meno, un embrione di società decente. Una società in cui le bambine potevano andare a scuola e le ragazze all’Università, in cui gli uomini e le donne potevano impegnarsi in attività economiche che non consistessero nella coltivazione dell’oppio, in cui per tanti, insomma, era possibile ricominciare a vivere, sperare di nuovo nel futuro. E’ facile immaginare che le democrazie più fragili, come la nostra, possano subire pesantemente le conseguenze della nuova situazione internazionale. Se non stiamo attenti, se non saremo capaci di mettere in campo efficaci contromisure, arriverà un tempo in cui l’Italia diventerà il terreno di scontro fra fazioni con referenti internazionali differenti, Europa e Stati Uniti da una parte, Cina, Russia e chissà chi altro dall’altra parte. Il partito filo-cinese ha già ora alzato la testa: «bisogna dialogare con i talebani che oggi si dicono più moderati di un tempo», «dobbiamo stabilire legami solidi con la Cina», eccetera. Anche gli amici italiani di Putin, sicuramente, non si faranno sfuggire l’occasione. Qualcuno invoca l’Europa. Ma l’Europa, nel bene e nel male, siamo noi. E c’è sempre il problema di come si fa a sollevarsi dal fango tirandosi da soli per i capelli. Ma comunque sono tante le domande che arrovellano la nostra mente in queste tornate di dolore. Da dove nasce la cieca follia che ha portato gli estremisti islamici di Kabul a farsi esplodere nel tormentato aeroporto della città, teatro da settimane di un esodo di massa degli occidentali e degli afhani loro collaboratori? Da dove nasce la violenza che tinge di rosso sangue il canale accanto allo scalo aeroportuale e che ributta l’intera area vent’anni indietro nel tempo? La risposta a queste due domande potrebbe certamente essere politica, frutto di un’attenta analisi storica di quanto accaduto in terra afghana, ma risulterebbe insufficiente, inefficace nel farci capire l’origine di tutto quest’odio. Esiste pertanto un’altra risposta che emerge dall’imminente ventennale dell’attentato alle Torri Gemelle. Chi ha vissuto quei giorni si ricorda certamente come furono trattati migliaia di uomini e donne innocenti: come simboli. Il grande limite dello jihad fondamentalista è quello di pervertire la dinamica della conoscenza religiosa: non la realtà come segno, come Parola e parabola da seguire e interpretare, ma la realtà come simbolo da conquistare per manifestare al mondo un potere, un’egemonia, che è quella di Dio. Si può dunque dire, a ragione, che la prima causa di quanto stiamo vedendo in queste ore di sangue è la mancanza di un rapporto autenticamente religioso con la realtà. È paradossale: non la religione, ma l’assenza di religiosità genera terrore, genera cosificazione della vita umana e svalutazione del desiderio di migliaia di persone che dall’Afghanistan vorrebbero solo fuggire. Anzi: quel desiderio non è avvertito come un dato da cui lasciarsi interrogare e cambiare, bensì come una minaccia da ricondurre al proprio controllo e al proprio potere. Avrà sempre paura del desiderio degli altri chi difetta del rapporto con Dio, chi ha ridotto quel rapporto a qualcosa di gestibile e razionalmente funzionale. Eppure la mancanza di religiosità non basta a spiegare tanta efferatezza, tanto spasmodico accanimento. C’è un altro fattore che purtroppo illumina un mistero così macabro. Chi ha negli occhi e nel cuore i giorni dopo l’11 settembre non può che ricordare le inaudite parole di Giovanni Paolo II che invitava il presidente Bush a perdonare i terroristi. Ma l’America orgogliosa e ferita non sapeva che cosa farsene di quel perdono e il Papa profetizzò conseguenze devastanti per la superpotenza, conseguenze figlie di quel mancato perdono che – per decenni – avrebbero perseguitato l’America, gli americani e i loro alleati occidentali. “La vera giustizia – disse l’anziano uomo polacco – è il perdono”. Proprio la mancanza di coraggio, il coraggio di perdonare, spiega tutto l’esacerbarsi di questi decenni: morte chiama morte, violenza chiama violenza, paura chiama terrore. E il cielo si fa sempre più buio sopra Kabul. In una logica di recriminazione e di cattiveria che ci riguarda tutti. E che annuncia un altro, imprevedibile, lungo inverno. Soluzioni al momento, non se ne intravvedono. C’è se non altro una lezione da recepire e di cui fare tesoro: che la democrazia non è merce da esportazione. In altri termini non può essere introdotta dall’esterno e dall’alto, come fosse un modello organizzativo aziendale stile McKinsey. Si conferma una verità se vogliamo antica: la democrazia non si regge solo sulla divisione dei poteri istituzionali e su libere elezioni, ma anche e innanzitutto su una realtà sociale di libere formazioni che tendono a convergere su obiettivi di bene comune, salvando le differenti esigenze e identità in un processo di riconciliazione. È stato così per l’Italia dopo la tragedia della seconda guerra mondiale. Forse non servono “soluzioni”, specie se ultimamente mirate all’affermazione di un posizionamento sullo scacchiere geo-politico delle egemonie. È finita, con l’esportazione delle democrazie, anche la pretesa di salvare il mondo con l’egemonia. Il problema è casomai come frenare o circoscrivere le mire egemoniche altrui, che siano russe o peggio cinesi. La democrazia non può che nascere dal basso, da esperienze esemplari, da un senso di appartenenza che prevale sulle diversità senza annullarle. Alla radice dal senso religioso degli uomini, sorgente del desiderio della persona e dei movimenti positivi della storia. Men che meno si esportano una cultura (se non come imposizione di un’egemonia ideologica o di una moda consumistica, che non sono cultura); né il cristianesimo, né alcun’altra religione. Non “esportarono” il cristianesimo i grandi missionari, dai gesuiti delle Reducciones in Paraguay a Matteo Ricci in Estremo oriente: lo fecero fiorire mettendo il seme nel cuore – religioso – delle persone e della comunità. Insomma: serve una logica di sussidiarietà, e non per modo di dire o per ripetere uno slogan. Al Meeting di Rimini si sono intravisti – per chi è stato attento – gli albori di una possibile, lunga, debole magari, ma non sostituibile strada di costruzione: precisamente nel dialogo tra importanti esponenti delle religioni musulmana insieme al cardinale Zuppi di Bologna. Essi hanno proseguito la riflessione e il confronto destato dalla pubblicazione dell’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco, il cui messaggio è penetrato come mai prima nella testa e nel cuore di persone e ambienti realmente religiosi delle tre fedi monoteiste. Essi desiderano non solo di riconoscersi fratelli perché figli dello stesso Padre sul piano religioso, ma anche di cooperare a una società amichevole, inclusiva e coesa, in cui ognuno si afferma non nella guerra ma nell’accoglienza dell’altro. Hanno fatto anche esplicito riferimento all’Afghanistan e alla gente che lì soffre, esortandosi vicendevolmente a pregare tutti per loro, a dedicarsi al soccorso dei deboli, a collaborare nell’apertura di corridoi umanitari per i profughi, a sostenere se possibile le opere buone delle Ong o di altre organizzazioni assistenziali per la popolazione. È un segnale piccolo e grandioso, come una scintilla che può generare un gran fuoco. Certo, bisogna alimentarlo.
Carlo Cammoranesi